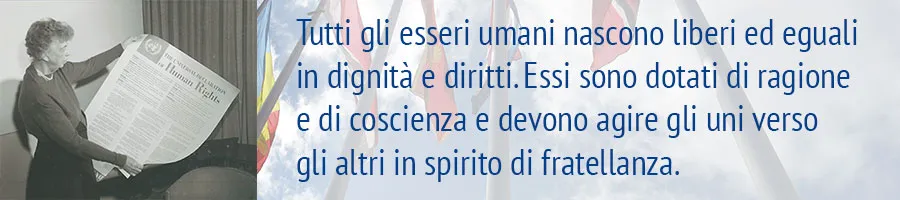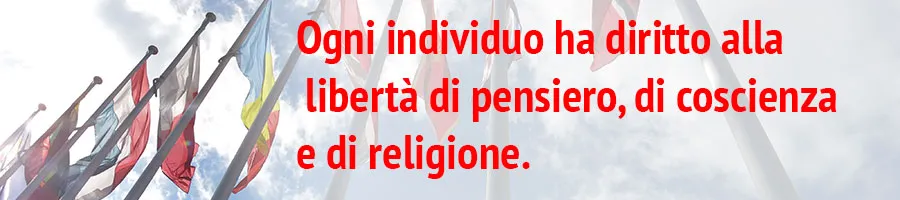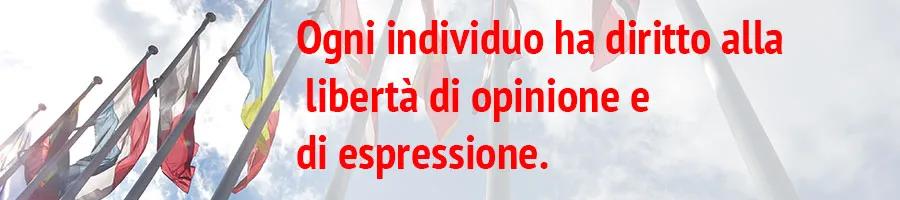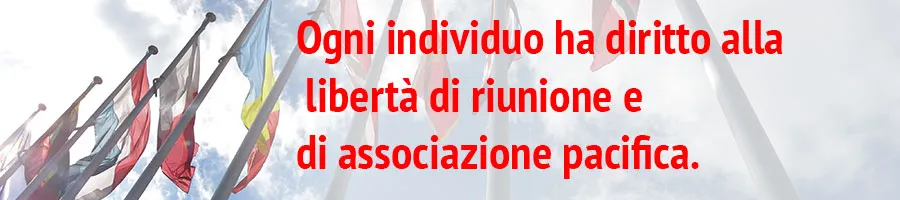In un mondo dove la spiritualità dovrebbe unire, la storia ci racconta che è accaduto spesso il contrario. Questo articolo, scritto dall’Avv. Prof. Pietro Nocita in concomitanza con le audizioni parlamentari sulla possibile reintroduzione in Italia del reato di plagio, offre una riflessione profonda e articolata sul concetto di religione, le sue ambiguità linguistiche e le sue derive storiche. L’autore, da sempre critico verso il reato di plagio — introdotto in Italia dal regime fascista e dichiarato incostituzionale nel 1981 perché contrario ai principi democratici — mette in luce come una certa intransigenza abbia generato persecuzioni, conflitti e contraddizioni.
Il Prof. Nocita ci guida in un viaggio tra diritto, storia e spiritualità, invitandoci a ripensare il credo non come vincolo, ma come possibilità di rispetto reciproco e convivenza. È fondamentale ricordare che nemici della democrazia e della libertà sono coloro che, tentando di reintrodurre un reato già dichiarato incostituzionale poiché incompatibile con il sistema democratico, mirano a reinserire nell’ordinamento giuridico italiano uno strumento utile solo a sopprimere il dissenso. Così come nelle dittature — di destra e di sinistra — il dissidente viene internato in ospedali psichiatrici, con la reintroduzione del reato di plagio chiunque, anche in assenza di prove, potrebbe essere accusato di “manipolazione mentale” e rischiare la detenzione in violazione dei basilari diritti umani e libertà fondamentali.
di Pietro Nocita — Il reato di plagio è stato dichiarato incostituzionale e tale reato non è dimostrabile in quanto il codice di procedura penale impone “non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato, e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”.
Il termine “religione”, così come tutti i vocaboli dello stesso significato utilizzati nelle diverse lingue europee, deriva dal latino religio lemma che indica ciò a cui si è scrupolosamente legati (dal verbo relègere) non solo per devozione e osservanza, ma anche per timore irrazionale. L’aspetto ambiguo del termine, che è una vox media, è espresso in modo evidente in Lucrezio presso il quale religio è il timore umano nei confronti degli dei che causa sciagure, quali il sacrificio di Ifigenia da parte del padre Agamennone in partenza per Troia: “Tàntum religiò potuìt suadère malòrum” (De rerum natura, I, 101/)
L’intransigenza nell’adesione ad una religione storicamente si è espressa tramite le persecuzioni, e non solo: l’avversione sistematica ad individui o a gruppi, a causa del loro credo, ha generato nei secoli violenza, negazione dei diritti e discriminazioni. Se le persecuzioni sono state pubblicamente motivate dall’intento “caritatevole” di convertire i nemici, ovvero di portarli sulla retta via della spiritualità, e presentate come atto necessario di professione di fede, occorre individuarne le motivazioni più profonde e reali nell’intolleranza religiosa, nelle esigenze politiche e nel profitto economico. A Roma le persecuzioni dei cristiani da parte di Nerone, Domiziano, Decio, Valeriano e Diocleziano, scatenate dalle accuse di minaccia all’ordine pubblico, erano di fatto legate al mancato riconoscimento della figura dell’imperatore e al rifiuto del suo culto. A partire dall’XI secolo, le crociate per la liberazione di Gerusalemme, lungi dall’essere ispirate da un sentimento di devozione al Santo Sepolcro, diedero ai paladini europei l’opportunità di arricchimento e il controllo commerciale delle rotte orientali. Così attualmente, secondo il report di Oxfam Italia, i conflitti cosiddetti religiosi sono in realtà il frutto di combinazioni di più motivazioni, etniche, politiche ed economiche come nei casi degli scontri ormai decennali in Yemen, Nigeria ed Etiopia.
Non solo il contrasto tra religioni diverse, ma anche la definizione dell’ortodossia in seno alle professioni di fede ha creato nei secoli tensioni e violenze. Gli albori della chiesa cristiana sono stati caratterizzati dalle dispute sanguinose tra diverse sette, spesso in contrasto teologico sulla natura di Cristo: ricordo, tra le altre, quella degli Ariani, che ritenevano Cristo creato e non generato, i Nestoriani che credevano Cristo scisso in due entità, quella di vero dio e quella di vero uomo, i Monofisti che professavano esclusivamente la natura divina dell’Unto di Nazareth. La disputa cristologica fu messa a tacere solo nel 325, quando 250 vescovi si riunirono a Nicea convocati dall’allora imperatore romano Costantino I. Con la dichiarazione di fede nicena, detta Symbolon, furono rinnegate tutte le dottrine gnostiche e stabiliti i canoni della religione cattolica. Tuttavia, non terminarono così le tensioni e le persecuzioni interne alla chiesa: gli eretici intransigenti vennero perseguitati e tutti i vescovi del concilio furono concordi nello stabilire che chi non avesse abbracciato il Symbolon sarebbe stato esiliato o condannato a morte. In quel periodo le violenze spesso gratuite e di massa come la famosa strage dei lapsi, coloro che sotto tortura dei Romani avevano rinnegato il cristianesimo, crearono non poche contraddizioni: tra queste il battesimo dello stesso Costantino, il gran persecutore, il quale ricevette il sacramento dal celebre vescovo ariano Eusebio di Nicomedia, dunque da un eretico.
Da allora la storia delle religioni ha continuato e continua ad essere costellata da contraddizioni e violenze sebbene, ed è importante ricordarlo, nessuna delle grandi religioni monoteiste inneggi all’intolleranza alla guerra. Attraverso libri, liturgie e lingue diverse Cristiani, Ebrei e Musulmani professano un verbo di pace, giustizia e tolleranza che ancora stenta ad affermarsi. La speranza per le generazioni future è che il credo personale e collettivo evolva in un sentimento di rispetto reciproco, rompendo finalmente i vincoli dell’ancestrale religio e l’intransigenza dei dogmi moderni.
Pietro Nocita