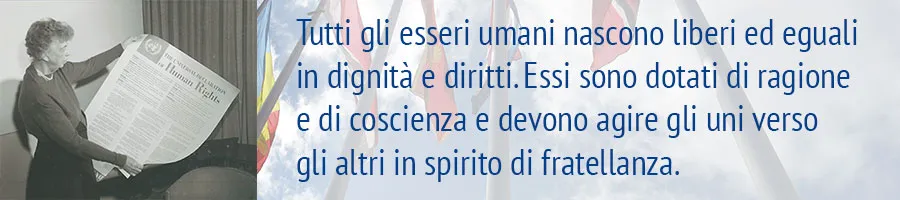Lo stato laico vorrebbe stabilire quali sono i “valori” religiosi accettabili
20 maggio 2017 - La prima sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.24084 del 15/05/2017 ha respinto l’istanza di un indiano di religione Sikh che aveva fatto ricorso contro una multa comminatagli per essere stato sorpreso con un coltello rituale (Kirpan), lungo circa 18 centimetri, portato fuori dalla sua abitazione senza un “giustificato motivo”. La richiesta è stata respinta in nome della sicurezza e della “conformazione” ai valori della società in cui l’immigrato risiede. Il Sikh aveva sostenuto che il pugnale, era un simbolo distintivo della propria identità religiosa e che il suo porto poteva trovare tutela nell’articolo 19 della Costituzione italiana.
I giudici, invece, hanno considerato il Kirpan un’arma e hanno riscontrato, nel suo trasporto fuori dall’abitazione, l’assenza di un “giustificato motivo”. In pratica si sono rifatti alla Legge n.110 del 1975, art.4, comma 2 che permette il porto d’arma impropria (es: coltelli, archi, forbici, attrezzi per le arti marziali, ecc.) solo nel caso di utilizzo per la loro destinazione propria. Per esempio, come la sentenza stessa recita “è giustificato il porto di un coltello da chi si stia recando in un giardino a potare gli alberi, o da un medico chirurgo che, durante le visite, porti nella borsa un bisturi. A fronte delle allegazione di circostanze di obiettivo rilievo dimostrativo,scatta l’onere dell’imputato di fornire la prova del giustificato motivo del trasporto” (2.1).
In verità il nostro Sikh aveva cercato di spiegare che il porto del coltello era giustificato dal suo credo religioso, ma il Collegio “pur a fronte dell’assertività dell’assunto, non ritiene che il simbolismo legato al porto del coltello possa comunque costituire la discriminante posta dalla legge” (2.2). In pratica, i Giudici hanno stabilito che, un simbolo religioso con le caratteristiche di un’arma, non è un “giustificato motivo”. Secondo la sentenza, anche la religione non può essere considerata una discriminante, perché: “In una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza di debbano riconoscere. Se l’integrazione non impone l’abbandono della cultura d’origine, in consonanza con la previsione dell’art.2 Cost., che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. È quindi essenziale l’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina. La decisione di stabilirsi in una società in cui è noto, e si ha consapevolezza che i valori di riferimento sono diversi da quella di provenienza ne impone il rispetto e non è tollerabile che l’attaccamento ai propri valori, seppure leciti, secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante. La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali confliggenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l’unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto d’armi e di oggetti atti ad offendere” (2.3).
I magistrati di Cassazione nel formulare la loro decisione si sono appellati anche all’articolo 9 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo che, al secondo comma, “stabilisce che la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui” (2.5).
Questa sentenza, a mio avviso, sebbene formalmente legittima in quanto, effettivamente, un pugnale è un’arma, e perché fondata sulla Costituzione italiana e sulla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, ha fatto, fa e farà discutere a lungo, a parte le facili polemiche da parte dei diversi schieramenti politici. Le discussioni non riguardano naturalmente il fatto che il legislatore abbia confermato il divieto di poter portare fuori di casa un oggetto che (pur carico di valenze simboliche e religiose) nel nostro ordinamento è di fatto un’arma ed è, quindi, vietato.
È lecito far rispettare l’ordinamento giuridico vigente, anche se forse sarebbe stata necessaria una maggiore attenzione alla dimensione spirituale e culturale di un gruppo religioso minoritario. Non è lecito, invece, dal momento che si riconosce la necessità della tutela del pluralismo (religioso, culturale ecc.) delle minoranze, invitare gli immigrati ad una passiva omologazione alla cultura e ai “valori” del paese ospitante. Ma a quali “valori” si riferisce la sentenza? Ai “valori” di chi? Della società italiana? Di quale parte della società italiana? Dell’Europa? Dell’America? Di quale America? Dell’Occidente? La parola “valori” è vaga, indefinita, portatrice di innumerevoli significati che cambiano nel tempo e con il mutare dei costumi e delle abitudini. Non è lecito voler piegare appartenenti ad altre culture e religioni ai parametri occidentali che, fra l’altro, non sono omogenei. Per lo stesso motivo, i cosiddetti “migranti” non possono e non devono costringere i congiunti ad accettare i “valori” della loro cultura se questi non lo desiderano.
I legislatori hanno, invece, ritenuto legittimo sostenere che i migranti che per un qualche motivo hanno scelto di vivere nei paesi occidentali abbiano “l’obbligo di conformarsi ai valori della società nella quale hanno deciso di stabilirsi” (2.3), ma è altrettanto legittimo, da parte nostra, criticare quell’obbligo e ritenere che in una società plurale come quella italiana, il processo integrativo necessiti di una maggiore e adeguata conoscenza della cultura e delle tradizioni religiose degli altri. Conoscenza e rispetto sono necessari per far nascere un vero processo di integrazione. Purtroppo, da noi i Sikh non sono ancora molto conosciuti e spesso, con i loro turbanti e la lunga barba, sono percepiti come legati alle religioni del Medio Oriente, per questo molti di loro (specialmente i più giovani), talvolta, cercano di minimizzare l’identità religiosa. Ma per la maggioranza essere un vero Sikh vuol dire indossare il turbante e portare il Kirpan che, secondo la tradizione, non può essere assolutamente paragonato (se non nella forma) ad un’arma.
La sentenza della Cassazione italiana quando afferma “l’obbligo a conformarsi ai valori della società occidentale nella quale hanno deciso di stabilirsi”, sembra dimostrare una certa incapacità di comprendere i diritti degli altri, delle minoranze culturali o religiose. Così, in nome della Legge, si possono ledere di Diritti dell’Uomo. È l’espressione di una certa ottusità dei legislatori del nostro Paese (ma anche dell’Occidente) che dilaga sull’onda della bugia e della disinformazione, la stessa che ha portato alla repressione dei Testimoni di Geova in Russia e alla legge anti-moschee, in Italia, più volte stigmatizzata da FOB.
Oggi, sembra che gli Stati stiano ripetutamente mettendo in atto l’inaccettabile pratica di travalicare i limiti del loro potere ledendo così i diritti umani.
Ma torniamo al nostro Kirpan che, come abbiamo detto, è un emblema religioso, un simbolo sacro, che nessun Sikh ha mai usato per aggredire od offendere. Nonostante la decisione della Cassazione, qualche tribunale italiano, fra le polemiche della Lega Nord, aveva precedentemente riconosciuto la legittimità del suo trasporto fuori delle abitazioni. Sentenze in tal senso erano state emesse, nel febbraio del 2009, dal Tribunale di Cremona e anche dal tribunale di Vicenza, che non a caso hanno sede in zone dove la cultura Sikh è maggiormente conosciuta a causa della forte presenza di immigrati provenienti dal Panjab. Queste sentenze (che avevano chiaramente stabilito che il Kirpan non può essere considerato alla stregua delle armi bianche; anche se, nel caso di Vicenza, il diritto al porto fu riconosciuto” perché la lama non era affilata”) testimoniano come le leggi possano essere variamente interpretate e come la conoscenza della cultura e della religione degli altri possa essere fondamentale per favorire il processo d’integrazione (per dettagli giuridici e considerazioni tecniche sulla sentenza del tribunale di Vicenza, si veda: G.I. Gatta, nella “Nota” al tribunale penale di Vicenza, ord. 28 gennaio 2009, in: “Il Corriere del Merito”, 2009, 5, pagg. 536 e segg.).
In India il Kirpan può essere tranquillamente trasportato fuori dalle abitazioni (art.25 della Costituzione); lo stesso diritto è stato riconosciuto anche dalla Corte Suprema del Canada in una sentenza del 2 marzo del 2006 (cfr. per dettagli: F. Astengo, La Corte Suprema del Canada afferma il diritto di portare a scuola il coltello dei Sikh, in: Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti). Nel Regno Unito una legge speciale autorizza i Sikh all’utilizzo del sacro pugnale.
Cerchiamo, ora, di dare un rapido sguardo alla religione dei Sikh per cercare di approfondire il significato religioso del Kirpan.
La religione dei Sikh fu fondata, attorno al 1500, da Guru Nanak (1469-1539), mistico e grande cantore della potenza e della grandezza di Dio. Il nuovo movimento religioso nacque e si sviluppò nel Panjab, un’area di confine fra l’Induismo e l’Islam, nel nord dell’India. Nanak cantava dell’esperienza ineffabile del Trascendente e predicava che: “non ci sono né hindu né musulmani…. Perché Dio non è né hindu né musulmano, e la via che io seguo è la via di Dio”. Nel suo insegnamento cercò di dimostrare l’assurdità delle pretese appartenenze religiose in base a ragioni prevalentemente esteriori, insistendo sulla necessità di una religiosità prevalentemente interiore.
Nanak predicava l’unicità di Dio: “Il Guru (Maestro) dei guru è uno solo, benché abbia diverse forme” (Asa Sohila, 2). L’eredità che lasciò ai suoi discepoli (“Sikh” significa: ”seguace”, “discepolo”) fu senza dubbio l’insieme dei sui canti religiosi, che costituiscono il primo nucleo del “Guru Granth Sahib”, il “Libro Sacro” conservato nel “Tempio d’Oro” ad Amritsar, nel Panjab indiano. Ma insieme al sacro Libro lasciò anche un secondo importante elemento di coesione: l’istituzione del lignaggio dei guru; nominò, infatti, come successore il prediletto Angad (1504-1552), conferendo così continuità alla tradizione. Si contano in tutto dieci “maestri” storici, Nanak più nove successori, in ciascuno dei quali i Sikh credono si sia incarnato, di volta in volta, lo spirito del fondatore.
Il decimo e ultimo successore, Govind Singh, fu un grande riformatore. A lui si deve, in un’epoca difficile di continue guerre, l’istituzione del Khalsa (1699) la “Comunità dei Puri” che conferì alla pacifica comunità dei Sikh il carattere distintivo di comunità militante di devoti pronti a dare la vita per difendere la propria fede. Da allora la religione dei Sikh ha sempre avuto questa duplice anima: da una parte la massima tolleranza ed una profonda spiritualità, come aveva predicato il Guru fondatore, dall’altro la fierezza e lo spirito guerriero. Non a caso, ancora oggi, all’interno dell’esercito indiano militano molti appartenenti a questa religione.
Nanak aveva caratterizzato la sua fede con due “formulazioni tripartite” (triratna). La prima comprendeva la “conoscenza” (gian), l’”amore” (prem), ed il “servizio” (seva); l’altra il “Nome divino” (Nam), la “generosità” (dan) e la “purezza di vita” (nan). Chi, invece, si riconobbe nella nuova istituzione della “Comunità dei Puri”, dopo una particolare cerimonia denominata “Amrit” (una specie di “battesimo”) doveva aggiungere una ulteriore triplice prescrizione, costituita da: “cucina comune” (deg), “vittoria” (fatah) e “spada” (teg). La condotta dei Sikh (che seguono il Khalsa) di allora è ancora quella di oggi: la loro è una vita regolata da precise normative (Rehat Maryada) che comprendono anche il controllo dei sentimenti negativi e l’astensione dal fumo e dall’uso di bevande intossicanti.
Sul loro abito indossano, ancora oggi, dei segni distintivi noti come i “5 K”, dall’iniziale “K” con cui iniziano i 5 nomi in lingua punjabi: barba e capelli lunghi (kesh), un piccolo pettine per fissare i capelli in crocchia alla sommità del capo (kangha) coperto dal turbante, pantaloni (kach) ampi (al posto della tradizionale tunica indiana: dhoti), un braccialetto di ferro (kara) e una spada o coltello (kirpan). Coloro che indossano questi emblemi di distinzione sono stati sottoposti al ”battesimo” rituale (amrit-pahal), hanno pronunciato le tre “rinunce” (rinuncia a vantarsi della propria posizione sociale o lavorativa, ad essere orgogliosi della propria origine, e a credere a superstizioni e fedi diverse) ed hanno aggiunto al loro nome l’appellativo di “Singh”, cioè: di: ”leone”.
Va ricordato, però, che non tutti i Sikh sono “amritdhari (“coloro che hanno compiuto la cerimonia dell’Amrit”), non tutti hanno preso i voti della “Comunità dei Puri”. Molti, non accettando le riforme marziali imposte dal decimo Maestro, preferiscono rimanere legati allo spirito dell’insegnamento originale di Nanak.
Il Kirpan, di cui in questi giorni tanto si parla per la sentenza della nostra Cassazione, per gli armitdhari non è un’arma ma la testimonianza di adesione al Khalsa e del loro impegno a difendere la fede. È una spada rituale generalmente portata in vita o appesa ad una cintura. Può essere portato sopra o sotto gli abiti e la sua dimensione può variare: dai pochi centimetri al metro di lunghezza quando è utilizzato in feste religiose, cerimonie e parate. La lama, ad un solo taglio, è normalmente d’acciaio o ferro ed il manico è spesso in metallo con riporti in legno e cuoio. Il Kirpan, di solito, è portato nella sua custodia, ben legato, anche se talvolta, in occasione di cerimonie religiose può essere sguainato. Il termine “kirpan” è composto da due parole: “Kirpa” che significa “misericordia” e “aan” che vuol dire “onore” e “dignità”.
Questa specie di spada sacra non è mai stata utilizzata (anche quando i Sikh si sono trovati a combattere) come arma offensiva e non lo potrà mai essere (al contrario di un’altra spada chiamata “talwar”, usata come arma difensiva). Il Kirpan simboleggia per il Sikh l’obbligo al coraggio nelle dure battaglie della vita e contro tutte le ingiustizie; è uno stimolo a lottare spiritualmente per il bene e a seguire una vita morale adeguata. In altre parole il Kirpan fa parte di una “divisa” religiosa ufficialmente e rigorosamente prescritta ed indossarlo significa seguire un insegnamento che fa della ricerca del bene e della giustizia nella società e nel mondo uno dei suoi fondamenti di fede.
Ciò nonostante il Kirpan, in Occidente, è stato spesso ritenuto “potenzialmente pericoloso” ed un rischio per la sicurezza dei cittadini. Sono abbastanza frequenti i casi (e non solo in Italia), in cui (specialmente agli aeroporti o nei luoghi pubblici) viene sequestrato. Per i Sikh è una offesa alla loro dignità. Come è piuttosto offensivo obbligarli a togliersi il turbante (sempre per motivi di sicurezza) anche se, il più delle volte accettano di buon grado di farlo per evidenti motivi di quieto vivere. In questi ultimi anni alcuni Sikh, cercando di adattarsi alle normative occidentali, hanno cominciato ad utilizzare Kirpan di minuscole dimensioni o in plastica o gomma. Ma sono solo ridicoli compromessi….
Il problema dei simboli che rappresentano una identità religiosa è assai complesso ed è strettamente connesso alla libertà personale. Da sempre le appartenenze religiose si esprimono attraverso il modo di vestirsi (dal saio, alla tunica, dalla kippah - il copricapo tradizionale ebraico - allo Hijab delle donne islamiche, per citare solo alcuni casi). Talvolta si possono usare anche oggetti più discreti come le spille sul bavero della giacca o i distintivi sul cappotto. D’altra parte, in un Paese libero e democratico, ciascuno dovrebbe poter vestirsi come vuole. Ma non è sempre così. E di fatti, negli Stati totalitari, talvolta, viene vietato di indossare certi abiti o certi distintivi. La libertà delle persone passa anche attraverso un abito o un simbolo.
Ma anche questo diritto, nei nostri Stati democratici, sta subendo limitazioni, spesso in nome della “laicità”. Basti pensare alla questione dello Hijab (il velo ) delle donne islamiche esplosa in Francia nel 2004, quando fu emanata una legge che vietava il “porto pubblico” dei simboli religiosi. Di tenore diverso, e per motivi di sicurezza, è il divieto di indossare abiti (ad esempio: il burqa) che impediscono di identificare chi li indossa. Ma anche in quest’ultimo caso, in un Paese libero, nessuno potrà vietare di indossare simili indumenti, anche se chi li porta non potrà rifiutarsi di mostrare il volto alla legittima richiesta di un agente di pubblica sicurezza. Esattamente come deve fare un Sikh quando all’aeroporto o all’ingresso in un pubblico ufficio gli viene chiesto di togliersi il turbante per verificare che non nasconda niente.
In Italia, è bene ricordare, che l’articolo 19 della Costituzione (al quale si era appellato il giovane Sikh condannato dalla sentenza della Cassazione) protegge il diritto di tutti a manifestare la propria professione di fede, e quindi di indossare abiti e simboli che attestino la propria appartenenza culturale o identità religiosa. Certo, un abito non è un pugnale e pur manifestando il massimo rispetto per le tradizioni dei Sikh non intendo difendere il diritto a portare in giro un oggetto potenzialmente pericoloso, anche se il vero significato della lama sacra può essere colto solo nel contesto del suo uso religioso, storico e culturale.
È lecito e doveroso far rispettare l’ordinamento giuridico vigente, anche se può nascondere il pericolo che la logica della sicurezza prevalga su quella della libertà e dei diritti. Garantire la salvaguardia dei cittadini è importante ma nella consapevolezza che la sicurezza è principalmente frutto di giustizia e garanzia dei diritti umani, prima che conseguenza di politiche di ordine pubblico.
Come si può obbligare gli immigrati a piegarsi ai parametri (i “valori”) della società nella quale hanno deciso di stabilirsi ? Oggi, il vero scontro di civiltà si gioca nelle aule dei tribunali e nei Parlamenti delle nostre società più o meno democratiche. La sfida va affrontata tenendo ben saldi alcuni capisaldi dell’esperienza giuridica occidentale: primo fra tutti l’affermazione della dignità di ogni essere umano, sulla quale poggiano il principio di uguaglianza e la conseguente affermazione dei diritti di libertà (inclusa naturalmente quella religiosa).
Non dobbiamo ne possiamo sacrificare sull’altare della “sicurezza” i diritti di libertà. Nello stesso modo si deve rifiutare ogni possibile ingerenza dei poteri dello Stato (nel caso della sentenza della Cassazione contro il Sikh: quello giudiziario) quando cercano di stabilire quali siano i “valori” da rispettare.
Mi auguro che queste brevi note possano contribuire a far conoscere meglio il grande valore spirituale che i Sikh attribuiscono al loro Kirpan e a far riflettere sull’importanza di una adeguata lettura della cultura e delle tradizioni religiose diverse dalle nostre.
Mai come oggi la vera sfida è quella di dare risposte (anche giuridiche) alle tante domande che, sempre più spesso, emergono dal contesto multi-culturale e multi-religioso della nostra società.
Prof. Silvio Calzolari
Segretario FOB