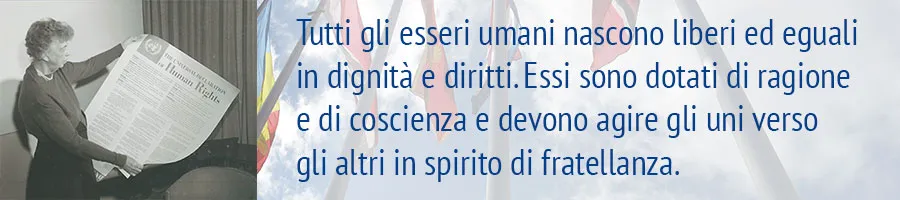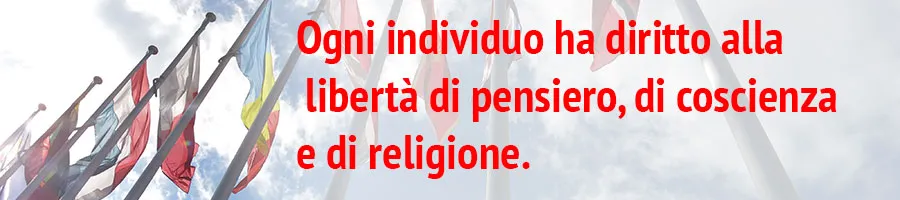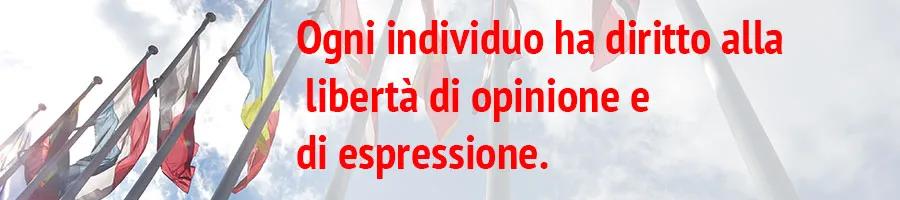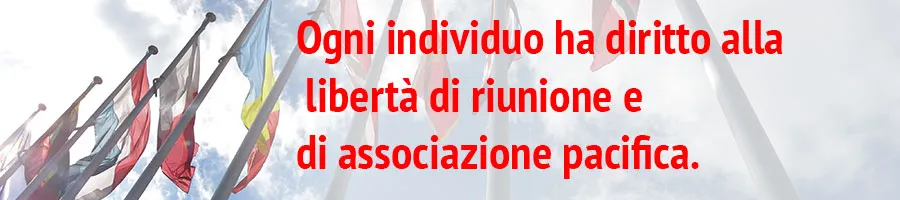"Il fanatismo voleva trovare il reo dopo aver immaginato il delitto"
(Pietro Verri, Osservazioni sulla tortura).
" ... concordi nella condanna di una giustizia dell'odio
che dopo un procedimento probatorio senza uguali nel nostro tempo
ha proclamato con granitica tranquillità il proprio pregiudizio"
(Karl Kraus, Morale e criminalità)
È stato riferito da giornali online che sarebbero stati i membri della "setta" cristiana Shincheonji Church of Jesus[1] a contagiare i sud coreani della città di Deagu. Questa "accusa" si fonderebbe sulla circostanza che fino a dicembre 2019 i membri della Shincheonji Church of Jesus avrebbero continuato a diffondere il loro credo religioso in Cina o tenuto un convegno o riunione nella città cinese di Wuhan, tornando poi infettati in Corea. Da Wuhan come è noto, è poi partito e si è sparso il contagio per tutto il mondo. Un titolo con cui questa "strana" notizia è stata pubblicata è "Coronavirus, polemiche e misteri sulla setta religiosa che ha scatenato i contagi nella Corea del Sud".
Non ha senso trattare più di tanto il fatto in sé o il suo contenuto di merito - vero o falso che sia - e neppure perdere tempo con le fonti. Si tratta di comunicazione tendenziosa contro la quale si pone l'evidenza rappresentata dalle circostanze che Whuan è una metropoli di 11 milioni di abitanti e che a dicembre 2019 si sono svolte manifestazioni sportive, musicali e di ogni altro genere; che le misure di prevenzione erano praticamente ancora inesistenti e che il "contagio" è stato così portato in "giro" per tutto il mondo dal pubblico ospite.
Quello che sembra più interessante, tale da giustificare la Nota, è l'uso del termine “misteri” e del'allocuzione "scatenato i contagi" che implica la colpa se non il dolo di propagare il contagio, unita al termine "setta" o "confraternita" sul quale viene trasferito il disvalore di quel togliere le catene e liberare il contagio in modo “misterioso”. In sostanza si tratterebbe di moderni "untori".
Il termine "untori" assume in Italia risonanza e importanze straordinarie perché quello degli "untori" è uno dei temi che ha formato oggetto dell'illuminismo italiano in particolare nell'attività dell'Accademia dei pugni e poi del Caffè e che ha dato luogo a due opere straordinarie come le "Osservazioni sulla tortura"[2] di Pietro Verri[3] e "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria[4]. L'accusa di essere un "untore" con il relativo processo non si limita ad essere stato oggetto della feroce critica dell'illuminismo italiano, in particolare di quella che era chiamata, anche in Francia, "Scuola milanese". Il termine "untore" infatti appartiene alla più generale cultura o almeno sensibilità di tutti gli italiani. In certo modo appartiene alla loro anima. Perché dolente e amaro il termine con tutto quanto indica appare in Manzoni, nei Promessi Sposi al redde rationem della grande peste e campeggiava già in Fermo e Lucia, tanto che la storia degli untori era divenuta un'appendice dell'opera maggiore e poi, opera autonoma nella "Storia della colonna infame".
Con buona pace di Croce e dello storicismo[5], la storia in sé è tragicamente semplice. Sulle accuse infondate di Caterina Rosa una "donnetta del popolo" vengono imprigionati, processati e condannati Guglielmo Piazza e il barbiere Gian Giacomo Morra. Il primo perde l'immunità promessa perché non riesce a sostenere la chiamata di correità nei confronti del barbiere che peraltro una volta entrato per calunnia in quel processo finisce come il primo sulla ruota. Del resto la correità, per dirla con il Manzoni, era davvero difficile da sostenere non essendoci in primo luogo il reato. Nulla però vale: i tempi erano quelli e dunque "temevano di non trovarlo reo" e, scrive il Manzoni, "è questa veramente la chiave di tutto" ("Storia della colonna, infame").
Introducendo il libro, Sciascia definirà quei giudici del processo agli untori, Monti e Visconti, "burocrati del male". Si diceva che avessero due qualità quella di avere ingegno ed essere onesti, ma, osserva Sciascia "due qualità che, nel caso, non potevano coesistere: perché era possibile fossero onesti ma imbecilli: o che fossero disonesti essendo intelligenti".[6]
La bottega del barbiere Morra fu rasa al suolo e sulle rovine eretta una colonna a monito, quella colonna che circa un secolo e mezzo dopo, divenuta "infame" per quel ignobile processo, fu demolita e la sua storia fu raccontata dal Manzoni. Ancora a monito, ma monito questa volta di infamia. Una lapide in latino seicentesco la ricorda nel Castello Sforzesco.
Untori moderni si è detto solo perché il vasetto con unguento del barbiere Morra è stato sostituito dalla invisibile presenza del virus dell’influenza micidiale.
“Dei delitti e delle pene” di Beccaria viene pubblicato nel 1764. Ma sempre per unire nel pregiudizio “untori” e “sette”, un anno prima in Francia vede le stampe il “Trattato sulla tolleranza” di Voltaire dal quale emerge il disastro causato dai pregiudizi religiosi.
Anche in tal caso un processo. La vicenda raccontata è semplice, a Tolosa, la famiglia di Jean Calas, protestate[7], un amico e la governante "zelante cattolica" vengono arrestati e inquisiti per la morte del figlio [8]morto impiccato. Dal gruppo di vicini cattolici richiamati dalle urla, viene avanzata l'ipotesi che siano stati i familiari, in quanto protestanti a uccidere il figlio, fratello e amico perché intenzionato ad abiurare il calvinismo e divenire cattolico. Questa ipotesi diventa rumorosamente certezza: Jean Calas ha ucciso il figlio per odio religioso[9]. Il processo, instaurato senza rispetto per la procedura, finisce con la condanna di tutti gli imputati. Non sulla base che di una sola prova, ma per la decisione a maggioranza dei giudici[10]. Jean Calas viene condannato alla ruota e viene giustiziato, ma invece di confessare, muore rimettendosi a Dio e chiedendo perdono per i sui giudici. Il fratello viene esiliato, le figlie rinchiuse in convento e la madre e moglie abbandonata.
La forza del “Trattato” di Voltaire, l’emozione causata dal racconto, il cambio d’umore dell’opinione pubblica impongono la revisione del processo e la revisione si concluse con l'assoluzione di tutti gli imputati, l'esilio del figlio fu revocato, le figlie, restituite alla madre[11].
Quello che appare singolare è una storia parallela che non riguarda virus ed epidemie. Una storia che attraversa come suo momento di rottura la storia dell'umanità ed è la storia dei grandi processi, delle sentenze ingiuste, delle condanne capitali degli innocenti. È la storia del pregiudizio ed è la storia della responsabilità delle comunicazioni, dei mezzi di comunicazione di massa e dei social media. Su queste storiche sentenze si fonda il nostro impegno di tolleranza, rispetto dei diritti, rispetto della libertà di credenza e di libertà religiosa.
Fabrizio d'Agostini
NOTE
[1] ⬆︎ La Sud Corea è al 50% buddista e per l’altro 50% cristiana nelle varie denominazioni e chiese protestanti o nuovi movimenti.
[2] ⬆︎ Viene pubblicato postumo anche se le idee di Pietro Verri influenzano profondamente Beccaria, tanto che un gran merito del lavoro “Dei delitti e delle pene” dipenderebbe dall’editing dell’opera fatta dal Verri. All’opera del Verri come a quella del Ripamonti si ispira anche il Manzoni della “Storia della colonna infame”.
[3] ⬆︎ L’opera nasce anche in polemica con il padre Gabriele Verri, Presidente del Senato lombardo che aveva ritenuto essere la “tortura” un insostituibile istituto processuale, respingendo la proposta di abolirla di MariaTeresa che già l’aveva abolita in Austria. La tortura sarà abolita come istituto processuale pochi anni dopo la pubblicazione di “Dei delitti e delle pene”.
[4] ⬆︎ Cesare Beccaria diventa il più importate degli scrittori dell’illuminismo italiano. Chiamato in Francia come esponente della scuola milanese, ritorna, preso dalla nostalgia, precipitosamente a Milano. Amico di Pietro Verri e di Alessandro Verri (fratello di Pietro) nell’Accademia dei pugni, viene spinto dai fratelli Verri a scrivere Dei delitti e delle pene sulla base del lavoro di Pietro. Gran affabulatore, divenuto famoso disconosce l’importanza del lavoro del Verri e il debito verso questi e l’amicizia si trasforma in inimicizia.
[5] ⬆︎ Il Manzoni che a differenza degli illuministi sposta il giudizio sul processo dalla tortura come istituto giuridico alla psicologia dei giudici, viene accusato di antistoricismo. Le condizioni storiche nelle quali avviene il processo agli untori a Milano (estate 1630) erano tali secondo i crociani da giustificare quel processo e quella condanna.
[6] ⬆︎ Sciascia difende espressamente Manzoni dall’accusa di antistoricismo.
[7] ⬆︎ Vengono chiamati genericamente protestanti i francesi ugonotti di fede calvinista.
[8] ⬆︎ Voltaire e poi i giudici di revisione (il Re) ritengono che si tratti di suicidio. Studi successivi avanzano l'ipotesi dell'omicidio indagando le frequentazioni del figlio.
[9] ⬆︎ Voltaire osserva "di lì a un momento nessuno ne dubitò più; tutta la città si convinse che è una regola della religione protestante che un padre e una madre debbano assassinare il loro figlio se questo si vuole convertire al cattolicesimo". Nel "Dictionaire philosophique", voce "Tolleranza", Voltaire osserva che "i cristiani sono i più intolleranti degli uomini". Del resto l'unica Crociata avvenuta in Europa e l'unica che ha avuto "successo" è quella contro gli Albigesi.
[10] ⬆︎ L'odio religioso si trasferisce nella camera di consiglio. Due giudici, l'uno fermamente convinto dell'innocenza della famiglia Calas e l'altro violento accusatore sono costretti entrambi a dimettersi, ma quello violentemente convinto della colpevolezza, adepto sembrerebbe della "Confraternita bianca", confraternita integralista cattolica, rientra in camera di consiglio e con il suo voto partecipa alla condanna. "Sembra" scrive Voltaire "che il fanatismo, da un po' di tempo indignato per i progressi della ragione, le si ribelli con più rabbia che mai".
[11] ⬆︎ Voltaire ne da notizia nell'ultimo capitolo del Trattato.