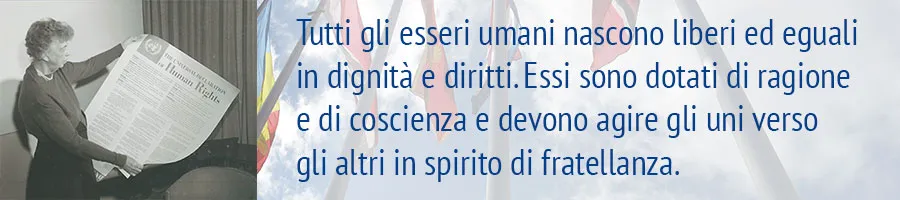Video e testo dell'intervento del Prof. Nicola Colaianni, Università di Bari, ex-Magistrato della Suprema Corte di Cassazione, al Convegno Internazionale Diritto e libertà di credo in Europa, un cammino difficile, tenuto a Firenze il 18-19 gennaio 2018
La libertà di credo in Europa alla prova dell’immigrazione e del terrorismo
ABSTRACT: L’Europa – la si intenda come Consiglio o come Unione – garantisce la libertà di credo. Ma l’assolutezza e l’ampiezza di questo diritto sono messe ormai a dura prova dal fenomeno immigratorio, che ha introdotto nuovi stili di vita, anche vistosi come l’abbigliamento femminile. L’ampio ricorso al margine di apprezzamento da parte della Corte EDU tanto quanto recenti arresti della Corte di giustizia UE rischiano di restringere tale libertà. Analogamente l’anticipazione della soglia di punibilità, come misura di contrasto al terrorismo, quando questo si autoconnota come di ispirazione religiosa rischia di restringere gli spazi della libertà religiosa. La Risoluzione europea del 25 novembre 2015 contiene delle linee guida in direzione di un recupero del garantismo attraverso la promozione di percorsi di prevenzione e di deradicalizzzione, di cui l’articolo esamina alcuni esempi.
SOMMARIO: Vecchi e nuovi limiti alla libertà di credo – 2. Il limite dell’organizzazione religiosa di appartenenza – 3. Il limite dell’organizzazione imprenditoriale con management di diverso credo – 4. Il limite dell’organizzazione imprenditoriale tout court – 5. Il limite del fenomeno migratorio – 6. Il limite del fenomeno terroristico – 7. Prospettive di riequilibrio
1. L’Europa garantisce ampiamente la libertà di credo. Riunita in Consiglio, dopo la seconda guerra mondiale, approvò la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, tra cui spicca all’art. 9 la libertà di religione o di credo, e quale Unione, pur inizialmente finalizzata a garantire altre libertà, non ha mancato di riprodurre quella norma nella Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza nel 2000, conferendole poi lo stesso valore giuridico dei trattati nel 2007 con il trattato di Lisbona. Non poteva essere diversamente dato il debito storico contratto a causa delle guerre di religione che avevano infestato il nostro continente più intensamente e incruentemente che gli altri. Le religioni erano diventate nazioni: cuius regio eius et religio. Non c’era libertà di religione o, più precisamente, essa era collegata alla libertà di circolazione da una regione all’altra, quella in cui la propria confessione era condivisa dal re. Senza garanzie per l’habeas corpus, come dimostra il caso emblematico di Miguel Serveto, l’eretico dichiarato che, rifugiandosi nella calvinista Ginevra, riuscì solo a sfuggire al rogo cattolico ma non a quello protestante.
Questo debito verso la libertà non fu certo saldato dal successivo atteggiamento liberale degli Stati. Da noi, per esempio, pur confermato nello statuto albertino il principio di Augusta a favore della religione cattolica, si stabilì contemporaneamente con la legge Sineo che comunque «la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari». Ma nel novecento la persecuzione religiosa ricominciò nei confronti degli ebrei (“Voi siete una religione o una nazione?”, li interpellò Mussolini) e, amplificandosi come persecuzione razziale, contribuì potentemente a determinarne lo sterminio di massa.
La seconda guerra mondiale provocò un deserto. Bisognava ricominciare attingendo a tutte le risorse disponibili ma represse, che in effetti come un fiume carsico tornarono in superficie. Si diede spazio alle dichiarazioni di libertà a livello internazionale ma, in Europa, con un’importante caratteristica: la giurisdizionalizzazione delle condotte degli Stati. Questi conservarono pienamente la propria sovranità nel giudicare ogni condotta dei cittadini, anche sotto il profilo delle libertà e, quindi, anche di quella religiosa, ma accettarono di sottoporre le proprie sentenze definitive al giudizio di una Corte internazionale sia pure a fini non di revisione ma solo di risarcimento danni. In un ordinamento di stati sovrani era forse il massimo ottenibile di cessione di sovranità. E il successivo conferimento alla Carta di Nizza di un valore identico a quello dei trattati ha aperto la strada, oltre che al sindacato, anche al rinvio pregiudiziale delle questioni dinanzi alla Corte di Giustizia.
L’ampiezza della tutela, certo non illimitata ma con limiti a loro volta limitati dai controlimiti, è entrata in sofferenza quando la giurisprudenza ha posto in bilanciamento libertà individuale e libertà dell’organizzazione religiosa. Questa nell’enunciato normativo europeo compare solo come una proiezione del diritto individuale nel contesto sociale: una facoltà, cioè, compresa nella libertà dell’individuo e non, come invece è avvenuto, un diritto autonomo dell’organizzazione, eventualmente contrapposto a quello dell’individuo. Certo, nei diritti statali c’è spazio anche per il riconoscimento dell’autonomia delle organizzazioni religiose ma per effetto di norme apposite (in Italia, per esempio, gli articoli 7 e 8 Cost.) e non del diritto individuale di libertà religiosa (per riprendere l’esempio italiano, l’art. 19 sotto questo profilo analogo all’art. 9 europeo).
Vero è, peraltro, che nel trattato sul funzionamento dell’Unione era stata inserita all’art. 17 la norma, originariamente contenuta in una dichiarazione priva di valore vincolante giuridicamente, sul riconoscimento delle chiese e delle organizzazioni filosofiche non confessionali come partners dell’Unione ai fini di un dialogo “aperto, trasparente e regolare”. E questa norma, benchè peraltro rimetta agli ordinamenti nazionali lo statuto di tali organizzazioni, non poteva non avere un effetto espansivo riconoscendo l’esistenza di nuovi interlocutori collettivi eventualmente contrapposti ai singoli cittadini nell’esercizio della libertà religiosa. E con ciò si ponevano le basi normative perché il diritto di libertà di credo, inizialmente riconosciuto ai soli individui – che certo possono esercitarlo anche in forma associata, ma non abdicandovi in favore della associazione che avevano contribuito a creare -, si aprisse alla fruibilità anche delle organizzazioni religiose. Con l’effetto che in caso di conflitto esso è soggetto al bilanciamento, in cui non è detto che prevalga senz’altro come dimostra la tendenza giurisprudenziale che passo a descrivere.
2. Questo nuovo limite alla libertà di credo era affiorato passim nella giurisprudenza ma forse mai come prima s’è manifestato nel caso Fernandez Martin [1] in cui, con una spaccatura verticale di nove ad otto la Corte europea dei diritti umani ha compiuto una svolta epocale stabilendo che la libertà religiosa dell’organizzazione di tendenza prevale su quella del lavoratore pur quando essa non intraprende e gestisce un’attività in proprio ma si avvale dell’amministrazione pubblica, alle cui dipendenze, benchè designato dall’autorità ecclesiastica, presta servizio il lavoratore.
Il caso riguardava il mancato rinnovo di un contratto di lavoro con lo Stato di un insegnante di religione – già prete, poi dispensato e sposato con cinque figli – siccome privato della idoneità ecclesiastica a motivo dallo «scandalo» derivante dalla pubblicità data da un giornale alla sua partecipazione all’incontro di un’associazione a favore del celibato facoltativo dei preti, che sosteneva anche posizioni dichiaratamente in contrasto con quelle ufficiali della chiesa cattolica in materia di aborto, di divorzio e di regolazione delle nascite.
La questione portata all’esame dei giudici di Strasburgo era se questa disciplina così intrusiva nella vita privata e penalizzante il diritto al lavoro di un cittadino europeo fosse “necessaria in una società democratica” o, detto in altri termini, se fosse ragionevole ed equilibrato il bilanciamento tra libertà religiosa della confessione e libertà religiosa, di pensiero, di associazione del cittadino. In particolare, si trattava di decidere se il dovere di lealtà di un dipendente dell’organizzazione tendenza fosse estensibile nella stessa misura anche al dipendente dello Stato, pur se designato dall’autorità ecclesiastica. La risicata maggioranza della Corte ha ritenuto di sì: tale differenza di status non rileva. Decisione irragionevole, che comunque non tiene conto che anche nelle organizzazioni di tendenza il conflitto è risolto previamente per effetto dell’adesione volontaria del prestatore di lavoro verso la tendenza dell’organizzazione, tale da costituire un requisito essenziale della prestazione ancorché “negli stretti limiti in cui essa sia funzionale a consentire” la realizzazione della tendenza ideologica. [2]
Questo contro-limite derivante dall’applicazione del principio di proporzionalità vale tanto più quando l’esercizio di quei diritti venga svolto non sul piano delle mansioni assegnate ma nella vita di relazione di carattere extralavorativo. Talvolta, invero, la natura della prestazione dovuta dal lavoratore subordinato richiede un ampio margine di fiducia esteso ai comportamenti privati, ma, come stabilito dalla Cassazione 6.2.2011 n. 3822 in linea di principio, “ove il comportamento del prestatore si estrinsechi in comportamenti che siano espressione della libertà di pensiero, la tutela di valori tutelati costituzionalmente (art 21 Cost) è tale da non essere recessiva rispetto a diritti—doveri connaturali al rapporto di lavoro, che, nella sostanza, non subiscono una compromissione per le modalità in cui si estrinsechino le condotte censurate”. [3]
Questo complesso di limiti e controlimiti alla libertà religiosa di un impiegato in un’organizzazione di tendenza non può non valere, e anzi va applicato ancor più rigorosamente, nelle situazioni ibride, come quella di specie, in cui il prestatore di lavoro è alle dipendenze dello Stato, ancorché per designazione – data la peculiare tendenza della mansione espletata – dell’autorità ecclesiastica. Questa, infatti, in tal caso non opera in proprio ma, a seguito di convenzioni o accordi di diritto pubblico, nelle strutture pubbliche e perciò non può non revocarsi in dubbio che nei confronti di un dipendente dello Stato possa far valere nella stessa misura e fino in fondo la propria libertà collettiva o “obiezione di coscienza”.
Quanto al contenuto sostanziale, è sleale – come opinato dalla Corte– per un insegnante di religione sposato ma noto quale former priest esprimere il proprio pensiero sul celibato opzionale dei preti o sul controllo delle nascite o sulla legislazione sull’aborto fuori della scuola in un incontro pubblico? E quanto alla pubblicità (foto e articolo su un giornale), che la Corte riconosce non essere stata cercata dal ricorrente, bastano quelle pubbliche dichiarazioni (public statements) ad integrare una condotta “fuori posto” (at odds) al fine della credibilità della religione insegnata nelle aule scolastiche? La Corte risponde affermativamente sulla scorta di tre precedenti che però, com’essa stessa riconosce, riguardano però lavoratori alle dipendenze di chiese e non dello Stato e conclusivamente motiva il carattere non sproporzionato o incostituzionale del provvedimento con il rispetto dovuto alla libertà religiosa collettiva o comunitaria della chiesa cattolica.
3. Per quanto non europeo, ma emblematico di una tendenza giurisprudenziale che si interfaccia con quella europea, lo step successivo è rappresentato dalla prevalenza nel bilanciamento di un’organizzazione non religiosa ma imprenditoriale, e neppure no profit ma for profit. Nello stesso torno di tempo la Corte suprema Americana adottava sempre a maggioranza risicata di 5 a 4 una decisione sui soggetti beneficiari dell’esenzione dall’osservanza dell’Obamacare a riguardo della copertura assicurativa per farmaci anti-concezionali e abortivi (cd. contraceptive mandate). Nelle linee guida essa è prevista per le sole non profit organizations a tendenza religiosa (charities, scuole, ospedali), in cui l’adesione ideale – anche nei suoi effetti collaterali (come la rinuncia a farmaci anticoncezionali o abortivi) – è un requisito essenziale e determinante della prestazione lavorativa. La Corte, nondimeno, ha allargato a dismisura la platea degli esentati, includendovi anche le for profit corporations, che producono o scambiano beni o servizi senza connotazione ideologica, per dir così neutri (nella specie si trattava di una catena di grandi magazzini per la vendita di articoli di bricolage con circa 13.000 dipendenti, la Hobby Lobby, e di una fabbrica di cucine e mobili componibili, la Conestoga Woods Specialties). La condizione è che si tratti di closely held corporations, cioè di imprese (oltre l’ottanta per cento, secondo dati statistici riportati dalla stampa, di tutte le imprese americane) possedute o gestite a livello familiare o comunque da un ristretto nucleo di persone, le quali ispirano la loro condotta imprenditoriale anche a ideali religiosi attraverso la performance of (or abstention from) physical acts” that are “engaged in for religious reasons”. Anche in questi atti si esprime l’“exercise of religion”, secondo la Corte, – neanche a dirlo: sincerely held, secondo la Corte, proprio con riferimento, nel caso, alla “religious belief that life begins at conception”. [4]
Il che non è dubitabile: ma le convinzioni del proprietario non mutano la natura neutra dell’attività imprenditoriale tanto quanto il fatto che, al limite, non si provvedesse alla distribuzione di utili (e non è questo il caso delle imprese che fruiranno dell’interpretazione della S.C.) non muterebbe la natura for profit dell’impresa. L’estensione della tendenza dall’attività oggettiva alla convinzione soggettiva dell’imprenditore è frutto della deviazione dal binario della pacifica interpretazione logica con la paradossale estensione della tutela del Religious Freedom Restoration Act del 1993 (RFRA):
- ad ogni person, cioè anche all’artificial person, alla persona giuridica, in quanto “Furthering their religious freedom also furthers individual religious freedom” e
- a tutti gli effetti indiretti, futuri ed incerti e perciò solo potenziali, dell’onere imposto a tali persons, giacchè nella specie si verte nel “providing health insurance that covers methods of birth control that may result in the destruction of an embryo” e, quindi, in una “conduct that seriously violates their religious beliefs”. Che ciò sia meramente eventuale, in quanto “that would occur only if an employee chose to take advantage of the coverage and to use one of the four methods at issue”, non rileva per la Corte: il semplice pagamento della polizza “is sufficient to make it immoral for them to provide the coverage”.
La persona giuridica diventa una specie di protesi della persona fisica del proprietario, la cui coscienza s’ingerirebbe anche nelle attività d’impresa, pur for-profit, al punto che i suoi convincimenti religiosi risentirebbero indirettamente della vessazione imposta alla sua impresa. Per impedire questa turbativa si produce una discriminazione dei dipendenti dell’impresa dell’obiettore rispetto a quelli di imprese di non obiettori o non closely held: e ciò per attribuire al credo di una persona, solo perché titolare di un’impresa, una protezione maggiore di quello delle persone che del credo dell’imprenditore finiscono per essere vittime.
4. Dalla contraccezione al porto del velo: il trend limitativo della libertà religiosa prosegue anche al di qua dell’oceano e s’incrementa con il passaggio dalla libertà religiosa dell’impresa alla libertà dell’impresa, tout court. Non c’è dubbio che la libertà di abbigliamento sia un tratto caratteristico, e anzi il più evidente, dell’identità personale, che si configura quale “diritto ad essere se stesso”. [5] Uguale è il sentire europeo: “religious dimension it is one of the most vital elements that go to make up the identity of believers and their conception of life” [6] sicchè “constraints imposed on a person’s choice of mode of dress constitute an interference with the private life as ensured by Article 8 para. 1 of the Convention”, come riconosciuto dalla Commissione europea per i diritti umani a riguardo di un travestito [7] e, nella scia, a riguardo di una ragazza indossante il velo integrale (il burka o il niqab). [8]
Per le norme proibitive del velo in pubblico, tuttavia, gli Stati finiscono per essere quasi sempre assolti dalla Corte EDU: la Svizzera perché l’insegnante non deve influenzare con quel powerful external symbol allievi di tenera età; la Turchia perché altrimenti la studentessa che lo porta all’università discriminerebbe le colleghe che non lo portano; la Francia perché in una struttura sanitaria si rischia di condizionare pazienti in stato di fragilità e dipendenza psicologica e soprattutto per il principio di neutralité de la puissance publique, per cui in altro caso è stato deciso addirittura che l’indossare il velo integrale anche se solo in particolari occasioni religiose come il Ramadan, e comunque solo per strada e non in caso di controlli di sicurezza, contrasta con il “living together in French society”, cioè la declinazione francese della democrazia, il cui “ideal of fraternity” richiede il volto scoperto come “the minimum requirement of civility that is necessary for social interaction”. [9] Il che, tra l’altro, significa ammettere versioni nazionali della democrazia, diverse l’una dall’altra: ed infatti in altro contesto, quello turco, la Corte ha riconosciuto la illegittimità del divieto di abbigliamento religioso (turbante, tunica e bastone, a simiglianza dei profeti, anche se a viso scoperto) [10], pur giustificato con la prevenzione del terrorismo.
Questa Europa a geometria variabile si accentua naturalmente nei rapporti privati, rimessi alle discipline nazionali sia pure con il limite del divieto di discriminazione, diretta o indiretta, posto dalla «direttiva-quadro» 2000/78/CE sulla parità di trattamento nei luoghi di lavoro. C’è discriminazione a motivo della religione ai sensi della direttiva citata? I casi C-157/15 e C-188/15 portati in via pregiudiziale all’esame della Corte di Giustizia riguardavano la receptionist di un’impresa fornitrice di servizi di accoglienza e un’ingegnera che, pur avvertita dei problemi che con il velo avrebbe potuto creare a contatto con i clienti, aveva preso ad indossarlo fin quando un cliente, dichiarando che esso aveva infastidito alcuni suoi collaboratori, aveva chiesto che non vi fosse “alcun velo la prossima volta” e la direzione le aveva imposto, senza successo, di non più indossarlo.
Le due decisioni, rese nella stessa giornata [11], escludono concordemente (la seconda richiamando la prima) una discriminazione diretta perché l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva “deve essere interpretato nel senso che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali” perchè “tratta in maniera identica tutti i dipendenti dell’impresa, imponendo loro, in maniera generale ed indiscriminata, segnatamente una neutralità di abbigliamento che osta al fatto di indossare tali segni”.
Ma solo a prima vista il divieto è neutrale perché si rivolge a tutti, anche ai cristiani e ai non credenti, certo, ma alla discriminazione in concreto soggiaceranno non loro bensì solo le donne musulmane (o gli ebrei con la kippah o i sikh con il turbante). Si tratta di un’evidenza che non ha bisogno di dimostrazione, ma che nondimeno la Corte rimette per la prova al giudice nazionale, legittimando così una disparità di interpretazione tra Stati dell’Unione su un diritto fondamentale dei cittadini europei.
Fatt’è che, se si ritiene incluso nella libertà dell’impresa, garantita dalla Carta di Nizza come si preoccupa di ricordare la Corte, anche il potere di determinare unilateralmente norme interne così invasive dell’altrui personalità, il lavoratore è spacciato nel suo diritto. La norma potrà anche essere formalmente uguale per tutti ma in concreto porrà un divieto solo a determinati lavoratori. Si perpetua, cioè, lo schema che denunciava due secoli fa Portalis, per cui tutti sono liberi di dormire sotto i ponti della Senna ma in realtà lo fanno solo i vagabondi di Parigi. La discriminazione indiretta è nei fatti e nient’affatto bilanciata o giustificata dai distinguo formalistici della Corte, che così finisce ancora una volta per considerare le persone uti mercatores e non uti cives.
Portare lo hijab, che è un semplice foulard e non il burka o il niqab, è diritto fondamentale da non comprimere salvo che danneggi in maniera irreparabile l’immagine, l’economia o la politica dell’impresa: Dietro a ogni hijab c’è una donna con il suo vissuto – di genere, di religione, di cultura, insomma di identità –, che il giudice di un’Unione dei diritti non dovrebbe consentire alle imprese di mortificare.
5. Fin qui si tratta di musulmani, prevalentemente, ma cittadini ormai europei. Tuttavia, non si può trascurare il problema della tutela inesistente della libertà religiosa di quelli migranti irregolari, fra cui richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale, che arrivano in Europa e, per quanto ci riguarda, sono trattenuti in cinque centri in territorio italiano. Istituiti nel 1998 dall’art. 12 della legge 40/1998, i Centri di permanenza temporanea, poi denominati CIE (Centri di identificazione ed espulsione) dalla legge 189/2002) e infine rinominati CPR (Centri di permanenza per i rimpatri) dalla legge 46/2017, sono strutture di detenzione amministrativa, in quanto sono privati della libertà personale individui che hanno violato una disposizione amministrativa, come quella del possesso di permesso di soggiorno: un regime di coercizione che, tra l’altro, impedisce loro di far valere pienamente il fondamentale diritto alla difesa legale, dimidiato e reso difficoltoso dalla l. 46/17.
Nel regolamento, approvato con DPR 394/1999, si stabilisce che, tuttavia, “fermo restando l’assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro”, devono essere garantiti “i diritti fondamentali della persona” e, specificamente, la “libertà del culto nei limiti previsti dalla Costituzione” (che, com’è noto, si riducono al divieto di celebrare riti contrari al buon costume) e la “libertà di colloquio (…) con i ministri di culto” (art. 21).
Dai rapporti di commissioni parlamentari e organizzazioni di volontariato emerge una frequente violazione di diritti fondamentali con una serie di violenze, rivolte, atti di autolesionismo, suicidi e morti all’interno dei Cie italiani. Non risultano violazioni del diritto di libertà religiosa, intesa nel senso specifico di libertà di seguire il proprio culto. Può certo darsi che ciò dipenda dal disinteresse dei denuncianti per l’esercizio di un diritto percepito come minusvalente rispetto ad uno stato di privazione della libertà personale ma è probabile che in effetti questo diritto non subisca limitazioni di fatto perché gli stessi responsabili dei centri lo avvertono come un fattore di integrazione e di mantenimento dell’ordine.
Ma avrebbe la giusta e normale pregnanza una libertà religiosa esercitata da persone private della loro dignità? È dignitoso, rispetta la dignità del migrante, garantirgli e agevolargli la pratica del proprio culto in un contesto soppressivo delle altre libertà, a cominciare da quelle di circolazione e di difesa? [12] Assicurare, per esempio, ai detenuti nei Centri, siccome musulmani osservanti, il diritto di professare il loro culto e associarli, siccome appunto musulmani, ad una etnia e alle organizzazioni terroristiche, rendendoli perciò soggetti a gravi limitazioni dei loro diritti, è sicuramente irrispettoso della loro dignità. Invero, l'art. 14 cpv. d. lgs. 286/1998, così come modificato dalla l. 189/2002, prevede che nei centri lo straniero sia trattenuto «con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità». E a tale scopo l’art. 19, co. 3, della l. 46/17 stabilisce che le stesse strutture siano “idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona”.
6. Dall’immigrazione al terrorismo il passo è breve. E l’odierno terrorismo ha molto a che fare con la religione, in particolare l’Islam, e la libertà di religione. In realtà, come ha considerato il Parlamento europeo nella Risoluzione 14.6.2016 COM (2016) 379 – particolarmente significativa perché volta alla “prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento dei cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche” – “il terrorismo e la radicalizzazione causano molti stereotipi in merito alle religioni, cosa che a sua volta provoca un inasprimento dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio motivati dal razzismo, dalla xenofobia o dall'intolleranza nei confronti di pareri, convinzioni o religioni”, laddove “è l'uso perverso della religione, e non la religione in quanto tale, una della cause della radicalizzazione”.
Questa considerazione istrada correttamente perché evita di ascrivere il terrorismo al fondamentalismo religioso, che nel superficiale cultural talk è sinonimo di fanatismo, nel quale in un libro sul nuovo terrorismo uno storico americano di origine tedesca, Walter Laqueur, ravvisa un elemento di follia, «specialmente del tipo paranoico». [13] Invero, il fondamentalismo è una nota caratterizzante movimenti prima di tutto ideologici, o teologici, che (come quelli riformati di Melantone e Calvino, i primi ad essere così definiti) propongono un ritorno radicale ai «fondamenti» di una dottrina: nel caso, quelli dell’islam originario, desunti da un’interpretazione letterale delle fonti religiose tradizionali (Corano e Hadith). E, come osserva Mahmood Mamdani (in Musulmani buoni e cattivi), non “può essere che una persona che prende alla lettera la sua religione sia un potenziale terrorista”. [14] Il problema nasce dal fatto che nell’islam sunnita, nel cui alveo si collocano i movimenti in questione, un’autorità esclusiva di interpretazione delle fonti scritturistiche non esiste. Di qui “l’alibi religioso del terrorismo” (M. Graziano, Guerra santa e Santa alleanza) perché il Corano “è ciò che i musulmani pensano che sia e ciò che vorrebbero che fosse». [15] La polinomia ermeneutica dei testi sacri nell’islam consente che per mille teologi musulmani che vi trovano la prova ultima e definitiva che uccidere è peccato, ve ne sono almeno altri mille che vi trovano invece la prova ultima e definitiva che uccidere è un dovere religioso. [16] Questo spiega perché i terroristi si sentano impegnati in una battaglia fra bene e male, che porta inevitabilmente alla guerra totale perché “these are matters of faith. These are matters of life and death”. [17]
Per definire il fenomeno sono molto utilizzati sintagmi come “terrorismo religioso” o di “matrice religiosa” o, più direttamente, “terrorismo islamista” o “jiadhista”. [18] Preferibile perché più neutro è il sintagma “ispirazione religiosa”, che può giovarsi delle disambiguazioni della giurisprudenza di legittimità in cui esso frequentemente si rinviene. [19] Esso, infatti, a differenza di quello della Risoluzione “matrice religiosa”, dà la percezione di un legame non oggettivo ma solo soggettivo tra terrorismo e religione: esso si limita a prendere atto che alcuni gruppi e movimenti terroristici giustificano la loro condotta con il richiamo ad un modello asseritamente religioso.
Organizzativamente questo tipo di terrorismo ha abbandonato la tradizionale forma piramidale di Al-Quaida, priva di radici sociali e caratterizzata dall’attacco al “nemico lontano”, per assumere quella della “rete”. Sulla base dell’“Appello alla resistenza islamica globale” (Da‘wâ ilâ al-muqâwama al-islâmiyya al-‘âlamiyyaem>) dell’ideologo siriano Abu Musab al-Suri, stretto collaboratore prima di diventare il maggior critico di Osama Bin Laden, Gilles Kepel ha definito questo fenomeno come “djihadisme de proximitéem>”, “prône à sa place la guerre civile en Europe, appuyée sur des éléments de la jeunesse musulmane immigrée mal intégrés et révoltésem>”. [20] Di qui un terrorismo individuale grazie ai vari social network, che consentono il c.d. fishingem> informatico non solo per foreign fighters ma anche per lone wolfem>, lupi solitari: basta mettersi a disposizione o segnalare un attentato che s’intende fare, in modo che possa essere rivendicato.
Perché il terrorismo di ispirazione religiosa mette a repentaglio anche la garanzia della libertà religiosa? A motivo delle norme di contrasto che gli Stati europei sono costretti ad emanare. Una risposta costituzionalmente orientata dev’essere improntata ad un’asimmetria massima tra la civiltà del diritto e la barbarie delle organizzazioni criminali: quindi, no al Diritto penale del nemico (Guantanamo), perché l’annullamento di garanzie è il miglior regalo che possiamo fare ai terroristi. Ciò premesso, bisogna tener conto però dello scadimento dell’efficacia general-preventiva della pena verso coloro che vedono nel martirio il coronamento della propria vocazione terroristica (i kamikaze). Di qui il ricorso ad un’anticipazione dell’intervento repressivo, con la configurazione del reato di pericolo nella semplice adesione all’organizzazione, che nel caso vale a dire ad un “nodo” della rete. Siamo in un campo che precede la soglia del tentativo. Scorriamo alcune di queste condotte:
art. 270-bis c.p.: Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex art. 270-sexies)
art. 270 quinquies Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, (…), con finalità di terrorismo. “persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;
art. 270- quater Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita. chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte
codice antimafia art. 4: pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti «a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche».
Non è possibile qui scorrere sia pur sinteticamente anche la giurisprudenza formatasi in questi anni, che evidenzia una serie di condotte ritenute preparatorie ma, isolatamente e cioè senza l’accompagnamento, penalmente irrilevanti e tra queste quelle di carattere religioso: quali il portare un testo del Corano o compiere atti di proselitismo o fare apologia di prescrizione come il porto del velo o le mutilazioni genitali femminili.
Tuttavia, la giurisprudenza apicale è consapevole della delicatezza della frontiera. Non si può anticipare oltre ogni limite: in particolare, non basta semplice proselitismo o indottrinamento, “finalizzati ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattenti in suo nome”. [21] In re ipsa è però il rischio di uno spostamento del baricentro verso componente psichica e, quindi, verso la stessa professione della propria fede religiosa.
7. Ho indicato alcuni limiti alla libertà di credo in Europa. Sono di nuova generazione perché o non deducibili espressamente dall’art. 9 CEDU o rivenienti dal diritto dell’emergenza (immigrazione e terrorismo). Essi circoscrivono, come cerchi concentrici, lo spazio di quella libertà. Tuttavia, i primi tre cerchi – l’organizzazione religiosa, l’organizzazione imprenditoriale ma governata da persone religiose, l’organizzazione imprenditoriale tout court – sono garantiti e sottoposti al sindacato giurisdizionale, ancorchè finora risultino prevalenti e prevaricanti. Negli ultimi due cerchi, invece, l’immigrazione e il terrorismo, la giurisdizione entra con molta fatica e non di rado per dare razionalità giuridica alle scelte del Parlamento in difesa dell’ordine democratico. Appare necessario un grande impegno politico e culturale per superare i pregiudizi diffusi sui migranti e sul binomio terroristi=musulmani ma anche, laddove si verifichino radici più o meno profonde nella rete terroristica, deradicalizzare i cittadini, italiani o ancora non divenuti tali, che potrebbero sostenere in qualunque forma lupi solitari o foreign fighters. L’obiettivo è quello della Risoluzione cit.: “sensibilizzare maggiormente, informare e istruire i lavoratori in prima linea (insegnanti, educatori, agenti di polizia, operatori che si occupano della protezione dei minori e lavoratori del settore sanitario) al fine di rafforzare la capacità locale di combattere la radicalizzazione” (n. 37) e “rafforzare la comprensione e la tolleranza, soprattutto nei confronti di religioni diverse” (n. 28).
Qualche segnale in questa direzione c’è: il ministero dell’interno ha promosso e finanziato un corso sulla formazione di cittadini appartenenti a confessioni prive d’intesa (quindi, prevalentemente musulmani e sikh) [22]; un’università (Bari) ha in corso di svolgimento un ben frequentato master sul tema. [23] Queste ed altre iniziative mirano a contrastare la radicalizzazione promuovendo le condizioni per un’integrazione sociale nel rispetto delle convinzioni cultural-religiose di ciascuno: cioè, una “cittadinanza laica”, consapevole e vivente di quella “distinzione degli ordini distinti” [24] che connota il nostro stato costituzionale di diritto e che sola può riparare la libertà di credo dagli attacchi provenienti non solo da quei nuovi prìncipi, che sono le organizzazioni religiose e imprenditoriali, ma soprattutto dalle emergenze migratorie e terroristiche.
Immigrazione e terrorismo sono il vero e attuale banco di prova della libertà in generale e della libertà di credo, che fu la prima ad essere affermata. Nei confronti dei già cittadini il problema è quello della progressiva prevalenza della libertà dell’organizzazione delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dei cittadini, secondo l’art. 2 Cost., rispetto a quella dell’individuo. Sono i nuovi “prìncipi” che, riconosciuti costituzionalmente come espansioni della libertà individuali, acquistano una propria autorità, che intendono affermare non solo nello spazio pubblico, grazie al principio di sussidiarietà orizzontale, ma anche in quello privato, prevaricando le persone che vi appartengono volontariamente, contribuendo a farli nascere e aderendovi, o che se ne pongono alle dipendenze per motivi di lavoro. Un problema di struttura, non esclusivamente europeo, ma anche degli Stati Uniti e, si può dire, di tutti i paesi di democrazia stabilizzata.
Il problema epocale è quello della libertà al cospetto della massima organizzazione ad appartenenza necessaria, lo Stato, e della sua legislazione di contrasto alla immigrazione e al terrorismo. Qui ad essere conculcata non è la libertà dei cittadini, ma quella dei non cittadini: tali per necessità o idealità, cioè vuoi perché la cittadinanza, pur desiderata, non è stata ottenuta (i migranti) vuoi perché, pur essendo stata ottenuta, non è desiderata, perché più importante è, per dir così, la “cittadinanza celeste”, cui i terroristi si sentono votati. Nell’uno e nell’altro caso non è neppure questione di libertà conculcate ma prima ancora di dignità disconosciuta: agli immigrati detenuti nei CPR italiani e soprattutto nei campi profughi libici con il contributo finanziario del nostro paese e il sostegno dell’Unione, e alle migliaia di vittime del terrorismo. Quale libertà, di credo o di altra specie, può riconoscersi a “non-uomini” (come Primo Levi definiva i muselmänner dei lager nazisti [25])? Questa è la dannazione del nostro tempo: fare di masse crescenti di persone materia inerte, senza nome, restando indifferenti alle loro sventure, giustificate ragionevolmente (la Ragione che per Rousseau avrebbe dovuto illuminare e liberare gli uomini!) come un prezzo non “eccessivamente alto da pagare per abbreviare il percorso, tagliare i costi e aumentare gli effetti”. [26]
Per frenare, se non invertire, questo trend distopico la tutela della libertà di credo continua ad essere uno dei principali indicatori del livello delle garanzie in Europa.
Nicola Colaianni
Università di Bari
NOTE
[1] ⬆︎ Corte europea dei diritti umani, Fernandez Martinez c. Spagna, 12 giugno 2014.
[2] ⬆︎ Cass. 16.6.1994, n. 5832.
[3] ⬆︎ Cass. 6.2.2011 n. 3822.
[4] ⬆︎ U.S. Supreme Court, Burwell v. Hobby Lobby Store inc., 573 U.S. (2014).
[5] ⬆︎ Così Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13.
[6] ⬆︎ Corte europea dei diritti umani, Eweida and others v. United Kingdom, 15 gennaio 2013.
[7] ⬆︎ Commissione europea per i diritti umani (Kara v. United Kingdom, 22 ottobre 1998)
[8] ⬆︎ Corte europea dei diritti umani, S.A.S. v. France, 1° luglio 2014.
[9] ⬆︎ Le quattro decisioni della Corte Edu sono rispettivamente la Lehila Sahin v. Turkey, 24 giugno 2004 e 10 novembre 2005 (grande Camera), Dahlab v. Switzerland, 15 febbraio 2001, Ebrahimian v. France, 26 novembre 2015 , S.A.S. v. France, cit.
[10] ⬆︎ Corte Edu, Ahmet Arslan and Others v. Turkey, 23 febbraio 2010.
[11] ⬆︎ Corte di Giustizia U.E, casi C-157/15 e C-188/15.
[12] ⬆︎ V. amplius, volendo, N. Colaianni, L’Europa e i migranti: per una dignitosa libertà (non solo religiosa), in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2018, n. 1.
[13] ⬆︎ W. Laqueur, Left, Right and Beyond: The Changing Face of Terror, in J. Hoge and G. Rose (eds), How did this Happen? Terrorism and the New War, Oxford: Public Affairs, pp. 71 ss.: “Madness, especially paranoia, plays a role in contemporary terrorism. Not all paranoiacs are terrorists, but all terrorists believe in conspiracies by the powerful, hostile forces and suffer from some form of delusion and persecution mania”.
[14] ⬆︎ M. Mamdani, Musulmani buoni e cattivi, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 22.
[15] ⬆︎ G.E. Fuller, A World without Islam, Brown and Company, Little, New York, 2010.
[16] ⬆︎ M. Graziano, L’alibi religioso del terrorismo, in http://gnosis.aisi.gov.it/gnosis/Rivista50.nsf/ServNavig/50-23.pdf/$Fil…
[17] Così Muhammad Shakir Auy, decano dell’Università di Karachi, alla giornalista Faiza Rahman, 19 settembre 2014 (tre mesi, dopo il 18 dic. 2014, il professore fu assassinato).
[18] L’aggettivo è usato nella proposta di legge D’Ambruoso A.C. 3558-A ma anche nella giurisprudenza penale.
[19] Da ultimo Cass. 24103/2017: “il richiamo alla Jihad islamica, che costituisce la fonte di ispirazione, dichiarata e non controversa, delle azioni militari dello Stato Islamico”.
[20] G. Kepel, con A. Jardin, Terreur dans l’hexagone. Genèse du Djihad français, Gallimard, Paris, 2015, p. 52.
[21] Cass. 48001/2016, che riforma GIP Bari 14/7/2016
[22] http://corsoculti.it; http://www.interno.gov.it/it/notizie/dialogo-interreligioso-concluso-primo-corso-integrazione-e-valori-costituzionali
[23] Si tratta dell’università “Aldo Moro” di Bari: v. http://www.uniba.it/master-universitari/prevenzione-radicalizzazione-terrorismo/master
[25] P. Levi, Se questo è un uomo. Einaudi, Torino, 1989, p. 81.
[26] Z. Bauman, Le sorgenti del male, Erickson, Trento, 2013, p. 74.