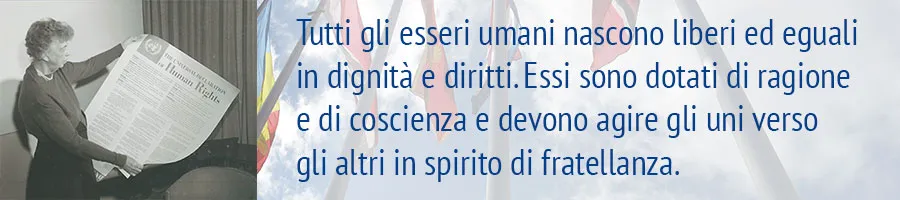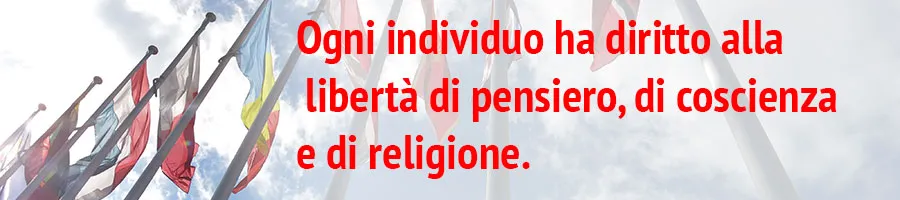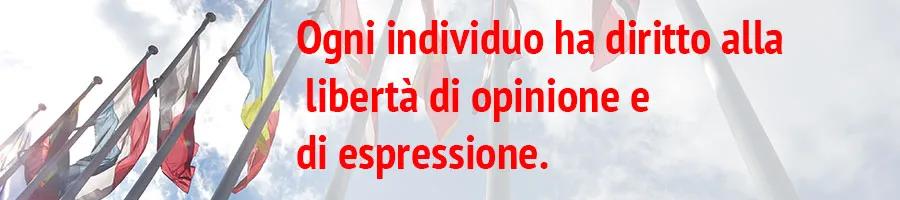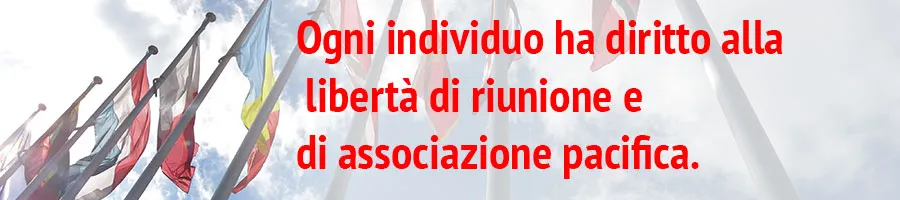In Italia è stata recentemente presentata una proposta di legge che mira a punire la manipolazione mentale, in particolare quella attribuita alle cosiddette “sette”, con pene da tre a otto anni di reclusione. In un’intervista pubblicata da Bitter Winter, l’avvocato Alessandro Amicarelli, presidente di Freedom of Belief (FOB), dialoga con il sociologo Massimo Introvigne, direttore del CESNUR, che esprime forti dubbi sull’efficacia e la legittimità del provvedimento. Secondo Introvigne, il disegno di legge si ispira a modelli già esistenti in Francia e Spagna, che si sono rivelati problematici e difficili da applicare. Molti esperti avvertono che una normativa del genere rischia di introdurre un reato vago e ideologicamente manipolabile, con conseguenze potenzialmente gravi per la libertà religiosa e di espressione.
Un parallelo storico significativo è offerto dall’articolo di Freedom of Belief “In memorria di Aldo Braibanti”, che ripercorre il caso di un intellettuale italiano condannato ingiustamente per “plagio”, un reato ormai abrogato, nato da sospetti verso l’indipendenza ideologica.
Chi decide cosa è “assurdo”?
Uno dei punti centrali dell’intervista riguarda la definizione stessa di manipolazione mentale. Introvigne sottolinea come non esista una nozione oggettiva e universalmente condivisa del fenomeno, e come spesso le valutazioni siano influenzate da pregiudizi culturali. L’intervista evidenzia come anche scelte religiose radicali — come quelle delle suore di Madre Teresa — siano state accusate di essere frutto di lavaggio del cervello. Questo porta a una riflessione più ampia: vogliamo davvero che siano i giudici a stabilire quali dottrine siano “normali” e quali “assurde”? Una situazione del genere sarebbe impensabile, ad esempio, negli Stati Uniti. Il rischio è che la legge finisca per colpire non solo casi reali di abuso, ma anche comunità religiose minoritarie che operano in modo legittimo e conforme alla legge. Un’analisi approfondita di queste distorsioni ideologiche è disponibile nell’articolo di Freedom of Belief “L’ideologia anti-sette e la FECRIS: pericoli per la libertà religiosa”.
Reati già punibili e il rischio di derive liberticide
Introvigne riconosce l’esistenza di abusi reali, come quelli commessi dalle “Bestie di Satana” o da sedicenti guru, ma sottolinea che tali crimini sono già perseguiti dal codice penale italiano. Introdurre una legge sulla manipolazione mentale potrebbe paradossalmente rendere più difficile perseguire questi reati, spostando l’attenzione da accuse concrete a imputazioni vaghe e ideologicamente orientate. Il timore è che la legge diventi uno strumento per colpire gruppi impopolari, applicando la giustizia in modo selettivo — dura con i deboli, indulgente con i forti — minando il principio di uguaglianza davanti alla legge.
Una proposta che nasce in un clima di ostilità religiosa e culturale
La proposta di legge non è affatto neutra: proviene dalla coalizione di governo e sembra recepire le istanze di gruppi come la FECRIS (Federazione Europea dei Centri di Ricerca e Informazione sul Settarismo), da tempo criticata per la sua ostilità verso la libertà religiosa. La FECRIS, pur dichiarandosi neutrale, ha avuto un ruolo controverso in Francia e mantiene legami stretti con ambienti russi dove la libertà religiosa è fortemente limitata, anche a causa delle pressioni esercitate dalla Chiesa ortodossa. In questo contesto, la proposta italiana rischia di importare modelli repressivi che minano il pluralismo e alimentano sospetti verso pratiche religiose legittime.
Laicità a geometria variabile
Questa proposta di legge, se approvata, rischia di compromettere ulteriormente la già fragile laicità italiana. Da un lato, i promotori, gli stessi che invocano la neutralità dello Stato quando si tratti di colpire le minoranze religiose; dall’altro, al contempo rivendicano la protezione delle “nostre tradizioni cattoliche”, negando di fatto i principi di laicità che si vorrebbero difendere. È una contraddizione che riemerge ciclicamente, nonostante il Nuovo Concordato del 1984 tra Stato e Chiesa abbia sancito l’indipendenza reciproca e il principio di laicità. In questo clima, la legge sulla manipolazione mentale rischia di diventare meno uno strumento giuridico e più un dispositivo ideologico per rafforzare l’influenza cattolica nella sfera pubblica — forse, ma forse no, come vedremo più avanti.
Una riflessione più ampia su queste dinamiche è proposta nell’articolo di Freedom of Belief “Italia, la grande paura del Ramadan e la necessità di una laicità matura”.
Un’arma a doppio taglio: il rischio trasversale della legge
Come sottolineato da Introvigne nell’intervista a Bitter Winter, i rischi di una legge del genere vanno ben oltre il suo potenziale uso contro le religioni minoritarie. Legislazioni simili in Francia, Belgio e Spagna sono state utilizzate da associazioni anti-sette per attaccare movimenti cattolici come l’Opus Dei, i Legionari di Cristo, il Rinnovamento nello Spirito e persino la nota Comunità di Sant’Egidio. Il termine “setta” è ambiguo e soggettivo, e gruppi protestanti fondamentalisti accusano regolarmente la Chiesa cattolica di essere manipolatoria. Ciò significa che la legge proposta potrebbe inavvertitamente finire per colpire proprio i principi e le istituzioni che i suoi promotori politici vorrebbero difendere — trasformandosi in uno strumento paradossale che mina gli obiettivi che si propone di perseguire.
Una legge di questo tipo, se approvata, rischierebbe non solo di rafforzare — direttamente o indirettamente — l’influenza confessionale nella sfera pubblica italiana; rischierebbe anche di danneggiare la stessa Chiesa cattolica. La sua ambiguità potrebbe dare forza ad attori liberticidi ostili alla libertà religiosa, trasformando un quadro già fragile di laicità in un crocevia di ideologie e agende politiche incompatibili.
Legge contro la manipolazione mentale in Italia: perché no
(Intervista pubblicata anche su Bitter Winter)
di Alessandro Amicarelli — Una proposta vorrebbe punire il “plagio” asseritamente praticato dalle “sette” con pene da tre a otto anni di prigione. Un’intervista a Massimo Introvigne.

Massimo Introvigne (sinistra) e Alessandro Amicarelli (destra) al recente convegno ESSWE 10
In Italia è stato introdotto un progetto di legge che vuole punire con la reclusione da tre a otto anni la manipolazione mentale (in pratica, un altro nome per il lavaggio del cervello), che sarebbe usato dalle cosiddette “sette” per reclutare seguaci. È vero che la maggior parte degli specialisti accademici di “sette” o nuovi movimenti religiosi sono contrari?
Sì, la stragrande maggioranza. Un appello in questo senso contro una proposta precedente, molto simile, fu sottoscritto dai più noti specialisti italiani e dai presidenti o segretari delle maggiori organizzazioni internazionali che riuniscono i sociologi e gli storici delle religioni. Lo stesso era avvenuto in occasione dell’approvazione della legge francese del 2001 (rivista e ulteriormente peggiorata nel 2024), cui la normativa proposta in Italia per molti versi si ispira. Certo, esistono nel mondo accademico internazionale anche studiosi con posizioni diverse, ma sono un’esigua minoranza tra gli specialisti di nuovi movimenti religiosi.
Perché si dovrebbe credere agli studiosi accademici e non alle “vittime delle sette”, che si fanno sentire per appoggiare il progetto di legge?
Per cinque buoni motivi. (1) Le cosiddette “sette” funzionano come porte girevoli: molti entrano ma molti escono. Gli ex-membri di movimenti religiosi controversi sono milioni. Le centinaia o anche migliaia che protestano non costituiscono dunque un campione rappresentativo. Studi scientifici dimostrano che anche nei gruppi più discussi oltre l’85% degli ex-membri non assume una posizione militante ostile al movimento che ha lasciato, ma rifluisce semplicemente nella vita sociale ordinaria, riconoscendo quando è intervistato aspetti positivi e negativi della sua passata esperienza. (2) Il campione di coloro che protestano è auto-selezionato: sono solo loro, e non la grande maggioranza di ex-membri schierata su posizioni diverse, a farsi sentire, inviare e-mail, contattare parlamentari. (3) Peggio, il campione è selezionato da associazioni “anti-sette” che hanno una loro precisa agenda pregiudizialmente ostile ai gruppi da loro definiti “sette”. (4) Nessuno si farebbe un’idea della Chiesa cattolica sentendo soltanto gli ex-preti che hanno lasciato il sacerdozio (o quella minoranza di ex-preti che protesta contro la Chiesa, perché anche in questo caso molti rifluiscono semplicemente nella vita sociale senza assumere atteggiamenti militanti), o di un personaggio pubblico divorziato fidandosi solo dell’opinione dell’ex-coniuge. (5) Anche nei casi – certamente esistenti – in cui le “vittime” riferiscono abusi reali, non è detto che le loro opinioni su come contrastarli siano più autorevoli di quelli di esperti dotati delle necessarie competenze professionali. Una vittima del terrorismo merita certo simpatia, e può descrivere in modo fedele la sua sofferenza, ma non è necessariamente autorevole quando propone ricette antiterrorismo.
Dunque ammette l’esistenza di abusi e violenze reali, dai maghi che violentano le loro clienti alle Bestie di Satana? E di fronte a questi orrori, come non essere favorevoli a una legge contro le sette e la manipolazione mentale?
Li ammetto certamente. Nel caso delle Bestie di Satana o di maghi predatori sessuali siamo in presenza di reati ovvi, già previsti e puniti dal Codice penale: omicidi, percosse, violenza carnale. Infatti, i tribunali hanno condannato i responsabili senza bisogno di una legge sulla manipolazione mentale. Anzi, sarebbe stato assai più difficile condannare le Bestie di Satana o questo o quel santone violento con un’imputazione vaga di “manipolazione mentale” che non per reati molto concreti e precisi come l’omicidio, la violenza carnale o le percosse. La situazione italiana è simile a quella della Germania e della Svizzera, dove non c’è una legge contro la manipolazione mentale, anzi commissioni nominate dai Parlamenti hanno raccomandato di non adottarla, eppure santoni e maghi a pagamento che si sono resi responsabili di reati comuni hanno subito severe condanne.

Un’immagine delle Bestie di Satana. Da X
Se l’esperienza dimostra che queste leggi sono di difficile applicazione, perché pensa nello stesso tempo che siano pericolose per la libertà religiosa?
Perché le leggi che creano reati vagamente definiti e su cui bravi avvocati e consulenti possono discutere all’infinito sono mine vaganti in balia del clima culturale dominante. Possono essere usate contro qualunque gruppo impopolare. Spesso sono forti con i deboli e deboli con i forti. In Spagna e in Francia sono state applicate contro gruppi piccolissimi e non in grado di permettersi grandi avvocati, mentre santoni miliardari e gruppi magari effettivamente colpevoli ma meglio difesi sono sfuggiti a ogni imputazione.
Ma le “sette” non sono religioni… Perché parlate di libertà religiosa?
La nozione di “setta” nasce nella sociologia delle religioni per identificare un gruppo religioso dove la maggioranza dei membri non è nata, ma vi ha aderito in età adulta. Secondo i sociologi che hanno usato per primi – fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento – questa nozione di “setta” il cristianesimo delle origini era una “setta”, che è poi diventata “Chiesa” dopo un paio di secoli. Come si vede, la nozione non comportava nessun giudizio di valore negativo. Oggi non è più così. “Setta” è nell’accezione comune un gruppo “pericoloso”. Ma la nozione è ambigua. Si può intendere come “setta pericolosa” un gruppo che commette reati previsti dal diritto comune (omicidi, truffe, violenze). Oppure si può dire che “setta” è chi diffonde idee e pratiche talmente assurde che soltanto tramite la “manipolazione mentale” qualcuno può davvero essere convinto all’adesione. Qui scatta il pericolo per la libertà religiosa, perché quali idee siano “assurde” può essere diversamente valutato a seconda dei pregiudizi ideologici di chi giudica. In base a quali criteri si ritiene che una “setta” danneggi i suoi seguaci? Per un laicista, l’atto della suora di Madre Teresa di Calcutta (1910-1997) che rischia la vita per assistere un malato contagioso terminale in India, che morirà comunque, è assurdo. E infatti non è mancata una letteratura che a suo tempo ha accusato Madre Teresa di praticare il “lavaggio del cervello”: come altrimenti avrebbe potuto convincere buone ragazze borghesi di New York o di Roma ad andare a pulire le piaghe dei malati terminali per le strade di Calcutta? In verità la distinzione fra “sette” e “religioni” (o fra religioni “vere” e “pseudoreligioni”) è del tutto soggettiva. La Chiesa cattolica è spesso accusata di essere “una setta” da gruppi protestanti fondamentalisti… e viceversa.

Suore dell’ordine di Madre Teresa, le Missionarie della Carità. Crediti
Ma non tutti sono Madre Teresa: non è forse vero che c’è chi millanta poteri divini per estorcere milioni ai seguaci o violentarli?
Qui occorre una distinzione rigorosa, che va al cuore del tema della libertà di religione e di opinione. Se qualcuno truffa, ammazza o violenta le persone non può nascondersi dietro lo scudo della libertà religiosa per sfuggire alla puntuale applicazione delle leggi sulla truffa o sui diversi tipi di atti violenti. Queste leggi ci sono già. Chi vuole introdurre il reato di manipolazione mentale vuole colpire chi non truffa, violenta o uccide nessuno ma induce i suoi seguaci a credere a dottrine che i promotori della legge considerano tanto assurde da potere essere abbracciate solo a causa di un “lavaggio del cervello”. A queste dottrine – come altri fanno per altre che invece sono socialmente approvate – i seguaci doneranno importanti somme di denaro, gran parte del loro tempo o magari tutta la loro vita. Chi fino a ieri era un professionista o una studentessa da domani condurrà una vita monastica o missionaria in condizioni di grande disagio. Il problema è come decidere quali di queste scelte sono “assurde” – quindi spiegabili solo con il “lavaggio del cervello” – e quali invece “normali”. Molti sarebbero d’accordo con l’affermare che la scelta delle suore di Madre Teresa è accettabile e anzi sublime, e quella di chi va a vivere in India come missionario di un santone accusato di pedofilia è “assurda”. Ma non tutti. Madre Teresa, come si è visto, fu accusata di praticare il lavaggio del cervello, e il santone ha i suoi difensori che assicurano che è ingiustamente calunniato. Vogliamo veramente trasformare i giudici in teologi e fare decidere da loro quali dottrine sono “assurde” e quali “normali”?
Ma la legge proposta non si occupa delle dottrine. Condanna solo le pratiche di manipolazione mentale…
In teoria. In pratica quali scelte siano “libere” e quali siano frutto di “manipolazione mentale” non può essere valutato a priori, ma solo a posteriori esaminando le scelte stesse. Se la scelta è giudicata accettabile da chi è chiamato a giudicare, si dirà che è libera; se è considerata inaccettabile, si dirà che deriva da una “manipolazione mentale” perché nessuno liberamente accetterebbe certe idee o certe pratiche “assurde”.
Ma non c’è una nozione oggettiva di “manipolazione mentale”, che si può definire prescindendo dalle dottrine?
No. Il tema della “manipolazione mentale” nasce storicamente da un problema che si poneva agli studiosi tedeschi, molti dei quali erano marxisti, al momento dell’ascesa del nazismo. Com’era possibile che non solo – come avrebbe previsto il loro marxismo un po’ rigido – i borghesi, ma anche molti “proletari”, diventassero nazisti? Utilizzando la nascente psicoanalisi, e combinandola con alcuni elementi della critica marxista della cultura, alcuni rispondevano che i “proletari” non diventavano nazisti liberamente, ma erano vittima di una “manipolazione mentale” da parte dei “pifferai magici” del nazismo. Dopo la guerra, e dopo che molti di questi studiosi tedeschi si erano trasferiti negli Stati Uniti, la stessa teoria fu applicata al comunismo. Il comunismo – si disse – è una dottrina talmente assurda che nessuno potrebbe abbracciarla liberamente; chi lo fa è vittima delle tecniche inventate in Russia e in Cina di “lavaggio del cervello”, un’espressione coniata nel 1950 dall’agente della CIA Edward Hunter (1902-1978). Verso la fine della Guerra fredda, il tema del “lavaggio del cervello” fu ripreso da psichiatri e psicologi ostili alla religione per attaccare il fervore religioso in genere: i primi attacchi furono portati contro i protestanti evangelicali e i cattolici dallo psichiatra laicista inglese William W. Sargant (1907-1988). Anche qui lo schema era lo stesso: nel mondo moderno certe idee religiose sono così “assurde” che l’adesione si spiega solo con il lavaggio del cervello. Più tardi, rendendosi conto che l’attacco alla religione in genere mirava a un bersaglio troppo grosso, fu soprattutto la controversa psicologa americana Margaret T. Singer (1921-2003) a restringerne l’applicazione alle “sette”. Ma rimaneva il ragionamento circolare: quali gruppi sono “sette”? Quelli che praticano il “lavaggio del cervello”. Come sappiamo che praticano il “lavaggio del cervello”? Perché sono “sette”, cioè le loro idee e pratiche sono così strane da non essere spiegabili con un’adesione libera.

William W. Sargant. Crediti
Ma queste teorie non hanno un loro posto rispettabile nella letteratura accademica?
Distinguiamo. La versione rozza, quella che sosteneva la propaganda anticomunista della CIA negli anni 1950, non appartiene certamente al mondo della scienza. Oggi nessuno userebbe più, come invece faceva nel 1953 l’allora direttore della CIA Allen Welsh Dulles (1893-1969), l’esempio del fonografo: nel cervello c’è un disco e i comunisti hanno semplicemente imparato a toglierlo e a cambiarlo. La versione più sofisticata – legata a nomi come Robert Lifton o Edgar Schein – può essere diversamente apprezzata a seconda delle opinioni che ciascuno può avere sulle teorie psicoanalitiche da cui ampiamente deriva. In ogni caso, questa versione più sofisticata non sostiene che la “manipolazione mentale” funzioni in modo “magico” o automatico, né che possa essere “isolata” prescindendo dalle dottrine al cui servizio si pone. In breve, la versione più “rispettabile” della teoria del condizionamento non può essere usata per definire reati. La legge deve essere per sua natura generale, e questa versione sostiene che ogni caso è particolare, e richiede un esame del contesto e delle dottrine. In realtà l’impianto ideologico che soggiace alla proposta italiana, come alla legge francese, è ancora quello grossolano “della CIA” secondo cui sarebbe possibile isolare la forma dal contenuto della manipolazione. Ma questa è un’impostazione teorica del tutto screditata tra gli studiosi di nuovi movimenti religiosi.
I movimenti religiosi “onesti”, compresi quelli cattolici, non hanno niente da temere dalla legge proposta, giusto?
Sbagliato. Tutto dipende da chi denuncia e chi giudica. Per alcuni, tanto più in un certo clima culturale dove ritornano scontri e anticlericalismi, anche la scelta di dedicare la propria vita, o di donare forti somme di denaro, a un’organizzazione cattolica, protestante o buddhista giudicata eccessivamente “rigorosa” per il clima culturale dominante può apparire “assurda” e tale da implicare necessariamente una manipolazione mentale. L’esperienza straniera insegna: gruppi come l’Opus Dei sono stati fra i più accusati in Francia, in Spagna di praticare la “manipolazione mentale” dai movimenti anti-sette. In Argentina gli stessi procuratori che perseguono le “sette” hanno avviato un’azione contro l’Opus Dei, accusata addirittura di traffico di esseri umani. I movimenti cattolici non sono affatto al sicuro. In Italia nella nostra memoria collettiva la sentenza della Corte Costituzionale del 1981 che ha eliminato il reato di plagio è collegata al caso del filosofo comunista omosessuale Aldo Braibanti (1922-2014). Ma in realtà la sentenza non è intervenuta sul caso Braibanti, ma su quello del sacerdote cattolico don Emilio Grasso accusato da alcuni genitori di “plagiare” i figli per avviarli al servizio dei poveri più poveri nelle periferie degradate. Ad alcuni un fervore cattolico di questo tipo poteva e può apparire “assurdo”, tipico frutto della “manipolazione mentale”.

Aldo Braibanti (1922-2014), l’unico cittadino italiano condannato per plagio con sentenza definitiva. Da X
Ma, appunto, la sentenza del 1981 della Corte Costituzionale che ha abolito il plagio non ha lasciato un vuoto legislativo?
Chissà come abbiamo fatto a sopravvivere a un vuoto legislativo durato oltre quarant’anni! No: la sentenza del 1981 – basta leggerla – non ha criticato quella legislazione sul plagio invitando il Parlamento ad approvarne un’altra, ma ha sostenuto che il “plagio”, così come era inteso allora ed è inteso oggi dai sostenitori del disegno di legge, è un reato immaginario, un escamotage per proscrivere idee impopolari o sgradite. Non potendo per ovvie ragioni costituzionali attaccare le idee, si afferma che idee così strane possono raccogliere aderenti solo grazie al “plagio” o alla “manipolazione mentale”, e si dice che sono queste tecniche – non le idee – che si vogliono incriminare. La Corte Costituzionale aveva bene inteso nel 1981 che si trattava, appunto, di un modo di incriminare le idee. Le sue argomentazioni rimangono perfettamente valide oggi, e dovrebbero indurre chiunque abbia a cuore la libertà a schierarsi contro qualunque tentativo di reintrodurre il plagio, comunque lo si chiami, nella nostra legislazione.