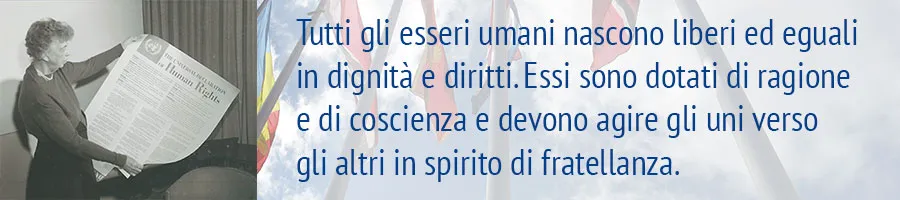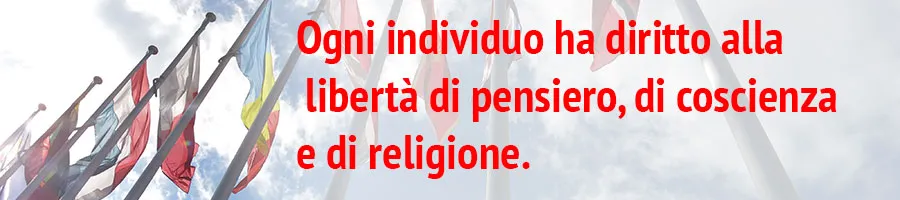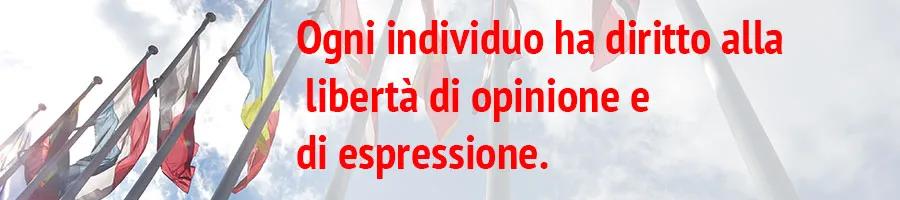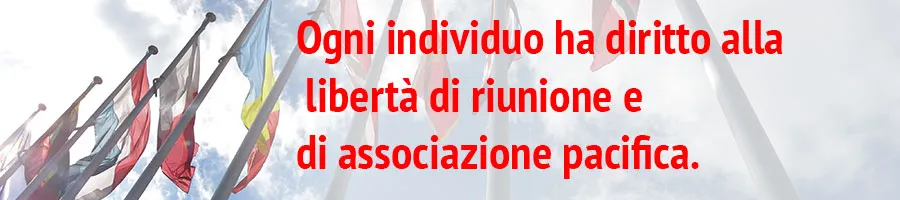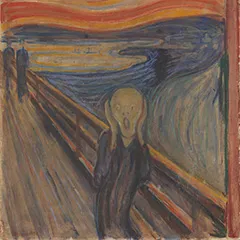
Nel nostro paese, ma non solo purtroppo, è in corso un’emergenza: un virus che si pensava debellato in modo definitivo già all’inizio degli anni ’80 del secolo scorso, ha fatto la sua ricomparsa.
Sta nuovamente circolando e si trasmette comunicando, scambiando idee, cambiando il proprio punto di vista e abbracciando nuove esperienze di vita. Si tratta del “virus della manipolazione mentale”.
Pare che l’unico vaccino in grado di fermare questo allarmante fenomeno sia una legge per controllare e limitare la libertà di cambiare opinione riguardo a qualcuno o qualcosa.
Ma cos’è la “manipolazione mentale”?
È una nuova etichetta per il plagio, un reato introdotto nel codice penale italiano durante il ventennio fascista, un’arma politica creata per controllare, azzittire e punire chi dissentiva dai dettami del regime. Con sentenza n. 96/81 la Corte Costituzionale italiana l’ha cancellato dal codice penale in quanto “incostituzionale perché indeterminato”.
Dopo i passati tentativi di reintrodurre il delitto di plagio da parte, tra gli altri, dei ministri Rosa Russo Iervolino e Giuliano Vassalli (1988) e del senatore di Alleanza Nazionale Renato Meduri (2001), nel 2006 nasce la SAS, Squadra Anti Sette della Polizia di Stato in collaborazione con don Aldo Buonaiuto della Comunità Papa Giovanni XXII e con il sostegno attivo dei gruppi anti-sette italiani. Il reato di plagio viene ora riproposto per l’ennesima volta, in duplice veste, con il nuovo nome di “manipolazione mentale” (senatrice Tilde Minasi, Lega) e “manipolazione emotiva e psicologica” (senatore Sergio Rastrelli, Fratelli d’Italia): un nuovo nome per un vecchio concetto che, specialmente nel mondo odierno dove spopolano i social media, potrebbe colpire chiunque.
Facciamo alcuni esempi:
Se un membro di una religione maggioritaria si converte a una fede minoritaria o a un movimento spirituale di frangia, viene a volte etichettato come vittima di manipolazione mentale; nel caso contrario, in cui un membro di una fede minoritaria si converte a una fede maggioritaria, si parla di “conversione”.
E che dire di influencer, insegnanti od opinionisti? Anche loro potrebbero essere accusati di manipolazione mentale, come è già successo negli anni ’60 del secolo scorso ad Aldo Braibanti (unica persona condannata per questo reato) o a Don Emilio Grasso all'inizio degli anni '80 (assolto in quanto la Corte Costituzionale ha depennato questo reato dal codice penale italiano).
Una persona sana di mente ha tutto il diritto di cambiare le sue idee siano esse di natura religiosa, filosofica o politica. E chi decide sulla sanità mentale di una persona? Forse gli “esperti” nel campo della salute mentale che, a seconda del vento che tira, sono pronti a dichiarare tutto e il contrario di tutto, proprio come accadde nell'Italia fascista e parimenti nella Germania nazista?
Questo ennesimo tentativo di controllo che vìola i diritti costituzionalmente garantiti parte dal presupposto che la maggioranza delle persone siano mentalmente disturbate e quindi non in grado di esercitare il loro libero arbitrio.
Si sta cercando di istituire una “polizia del pensiero”? Un obbrobrio in una società che si definisce democratica.
Sebbene l’art. 603 c.p. sia stato abrogato, nel nostro ordinamento esistono leggi che prevedono sanzioni e condanne per chi le vìola a tutela di persone fragili o vulnerabili come nei casi di circonvenzione di incapace, violenza privata, minaccia, istigazione, stalking, ecc., quindi a beneficio di chi si sta nuovamente cercando di introdurre il defunto reato di plagio?
È vero, in ogni gruppo o movimento di varia natura possono esistere singoli individui che si macchiano di reati, ed è giusto che la legge venga fatta rispettare, ma si sta parlando di individui, non di un gruppo o un movimento in toto. Si sta cercando di “buttare via il bambino con l’acqua sporca”.
Una caratteristica comune a questi disegni di legge è l’urgenza imposta dalla presunta “crescita allarmante del fenomeno delle sette e dei culti distruttivi”, con numeri improbabili forniti dai gruppi anti-sette. L’allarmismo generalizzato di cui sono infarcite le relazioni introduttive ai disegni di legge fa il paio con l’allarmismo veicolato dai mass media, contribuendo a creare la fantomatica urgenza per la reintroduzione del reato di plagio, quale che sia il nome che gli verrà dato. L’articolo che segue a firma Willy Fautré né è un chiaro esempio. Per approfondire si segnalano anche i seguenti articoli:
- I fuoriusciti: la responsabilità dei media e dei politici
- Se l'informazione diventa spettacolo ai danni della realtà
- IL POTERE DEI MEDIA: promuovere o minare la libertà religiosa
Ci auguriamo che i nostri legislatori prendano seriamente in considerazione le conseguenze e i danni che una legge del genere potrebbe causare e che la loro primaria motivazione sia la protezione dei principi costituzionali e non quella di guadagnarsi un inesistente consenso popolare.
BELGIO – REGNO UNITO: Il ruolo dei media nella stigmatizzazione delle minoranze religiose
 Di Willy Fautré, director of Human Rights Without Frontiers (HRWF) — Dall'1 al 3 agosto 2025, la HJ International Graduate School for Peace and Public Leadership (HJI) ha convocato la sua terza conferenza internazionale a New York sul tema “Le cause alla base delle minacce contemporanee alla libertà di religione”.
Di Willy Fautré, director of Human Rights Without Frontiers (HRWF) — Dall'1 al 3 agosto 2025, la HJ International Graduate School for Peace and Public Leadership (HJI) ha convocato la sua terza conferenza internazionale a New York sul tema “Le cause alla base delle minacce contemporanee alla libertà di religione”.
In quell'occasione, HRWF ha presentato un documento intitolato “Il ruolo dei media nella stigmatizzazione e ostilità nei confronti di alcune minoranze religiose o di credo”.
L'articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) tutela il diritto individuale alla libertà di religione o di credo, di praticarla da soli o in comunità con altri, in pubblico o in privato, di manifestare la propria religione o il proprio credo attraverso il culto, l'insegnamento, la pratica e l'osservanza.
La formulazione è molto simile a quella della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, così come lo sono altri strumenti internazionali che tutelano la libertà di religione o di credo.
La questione della terminologia
Le Nazioni Unite, la Corte Europea dei Diritti Umani, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e altri meccanismi internazionali utilizzano terminologie neutrali nell'identificare una comunità religiosa o di fede nelle loro dichiarazioni, relazioni o sentenze.
In Europa, i media e altri addetti all'informazione e alla comunicazione non sono soliti adottare questa prassi nei confronti di una serie di movimenti religiosi o di credo che identificano come “cult” in inglese o varianti della parola “sette” nelle lingue latine, germaniche, scandinave o slave, termini che sono ormai caratterizzati da una connotazione negativa. Negli ultimi decenni, questa categoria negativamente connotata di “culti” o “sette” è stata artificialmente costruita per cercare di escludere alcuni gruppi religiosi o di credo dalla protezione dell'articolo 9 della CEDU. Di solito, i principali promotori di questo movimento caratterizzato da ostilità erano e sono ex membri scontenti, desiderosi di vendetta.
Le Nazioni Unite e la Corte Europea dei Diritti Umani, la cui giurisdizione si estende a 46 Stati europei, non approvano questa distinzione e categorizzazione discriminatoria e dispregiativa.
Il 12 dicembre 2022, nella causa “Tonchev e altri c. Bulgaria” (ricorso 56862/15) che vedeva coinvolte tre Chiese evangeliche e pentecostali in Bulgaria, la Corte Europea ha insistito ancora una volta sul fatto che le autorità pubbliche non possono utilizzare un “linguaggio peggiorativo e ostile” nei propri documenti ufficiali, come ad esempio definire una religione minoritaria una “setta”.
Sentenze analoghe erano già state emesse dalla CEDU in diversi altri casi.
Il 23 novembre 2021, nel caso “Centre of Societies for Krishna Consciousness in Russia and Frolov v. Russia” (Ricorso 37477/11), la CEDU si è pronunciata contro un opuscolo russo che aveva definito l'ISKCON, noto come movimento Hare Krishna, “setta totalitaria” e “setta distruttiva”, concludendo che “utilizzando un linguaggio dispregiativo e affermazioni prive di fondamento per descrivere le credenze religiose del centro ricorrente”, il governo russo aveva violato la libertà di religione dell'ISKCON.
Il meccanismo che genera stigmatizzazione, ostilità, intolleranza e persino violenza
La classificazione di alcuni gruppi religiosi, spirituali o di credo come “sette”, oltre che come pericolosi, dannosi o totalitari, è innanzitutto opera degli “anti-sette” o “anti-cultisti”. Si tratta di individui, apostati, associazioni anti-sette o anche di autorità pubbliche e istituzioni statali.
L'uso improprio di queste etichette dispregiative, usate senza alcuna remora dagli anti-sette, ha causato molti danni a queste minoranze religiose e ai loro membri sia nella loro vita personale che in quella professionale.
Tuttavia, anche i media hanno la loro parte di responsabilità nella stigmatizzazione, ostilità, intolleranza e danni causati agli individui quando per sensazionalismo pubblicano, senza indagare e verificare, accuse tendenziose e false degli anti-sette, diffondono le loro fake news e talvolta bugie piuttosto grossolane. In questo modo creano un clima di sospetto e ostilità che a volte sfocia in crimini d'odio e atti di violenza che hanno conseguenze letali, anche in Europa.
Un caso giudiziario di grossolane menzogne.
Nel 2020, FECRIS, l'organizzazione ombrello dei movimenti anti-sette europei con sede in Francia, ha subito una storica sconfitta in una causa celebrata presso il Tribunale Distrettuale di Amburgo, in Germania, dove è stata giudicata colpevole di 18 accuse di falsità nei confronti dei Testimoni di Geova.
In un comunicato stampa, la FECRIS ha falsamente affermato di aver vinto la causa che in realtà aveva perso.
Poiché i Testimoni di Geova avevano sostenuto che 32 dichiarazioni della FECRIS erano diffamatorie e la Corte ne ha giudicate diffamatorie “solo” 17, una parzialmente diffamatoria e 14 non diffamatorie, la FECRIS ha affermato di aver difeso con successo il proprio caso ad Amburgo. Ciò che FECRIS ha omesso di dire è che ha dovuto pagare un risarcimento monetario ai Testimoni di Geova tedeschi per essersi resa colpevole di 18 capi d'accusa di diffamazione.
Le false accuse mosse dagli anti-sette, ad esempio quelle di abusi sessuali, che fanno notizia sui media, non sono rare e possono avere ripercussioni molto gravi sull'immagine di un gruppo religioso, anche se in seguito vengono dichiarate infondate dai tribunali.
Il ruolo dei media: casi concreti nel Regno Unito e in Belgio
Le accuse infondate amplificate dai media non solo influenzano l'opinione pubblica e rafforzano gli stereotipi, ma plasmano anche le idee dei decisori politici e possono persino essere ufficialmente avallate da alcuni Stati democratici e dalle loro istituzioni.
Due esempi concreti di fake news diventate virali. Il primo riguarda la copertura mediatica di un recente evento di Scientology nel Regno Unito e il secondo riguarda la copertura mediatica di una notizia falsa riguardante i Testimoni di Geova e presunti abusi sessuali.
Caso uno: all'inizio di novembre 2023, l'Associazione Internazionale degli Scientologist (IAS) ha celebrato il suo 39° anniversario a Saint Hill, East Grinstead (West Sussex), a circa 20 km dall'aeroporto di Gatwick. Tre giorni sono stati dedicati a questo evento che, dopo quattro anni di interruzione a causa del COVID, ha visto la partecipazione di circa 7000 persone provenienti da tutti i continenti.
Una settimana prima, una grande manifestazione anti-Scientology organizzata da un ex membro scontento era stata annunciata dal The Guardian come «la più grande dal 2008 organizzata dai membri del gruppo internet Anonymous fuori dalla sede centrale della chiesa a Londra, che ha attirato più di 300 persone». Secondo i manifestanti anti-Scientology, che hanno sottolineato che il sito web del quotidiano raggiunge 110 milioni di lettori unici al mese, l'articolo è stato uno dei dieci più letti di quel giorno.
Gli organizzatori avevano anche annunciato che la strada per Saint Hill sarebbe stata chiusa dalle 14:00 alle 22:00 per la loro manifestazione del 3 novembre, ma ciò non è mai avvenuto.
Lo stesso giorno, anche Newsweek e The Express si sono uniti e hanno amplificato la stessa operazione anti-Scientology, annunciando anch'essi lo stesso “raduno di massa” contro il movimento e/o i suoi leader. Tuttavia, un evento così imponente non ha mai avuto luogo.
Non ci fu alcun raduno di tale portata: «46 manifestanti hanno marciato da East Grinstead e si sono riuniti presso la sede di Scientology, rendendo questa la più grande protesta anti-Scientology dai tempi del movimento Anonymous, 15 anni fa», secondo quanto riferito dagli stessi organizzatori. Solo 46 contro i presunti oltre 300 manifestanti del 2008, ovvero sette volte meno... e l'hanno annunciata come la più grande degli ultimi 15 anni.
Durante i tre giorni dell'evento, nessuna manifestazione del genere è stata visibile o udibile sulla strada per Saint Hill o vicino all'ingresso, poiché la polizia li ha tenuti a distanza.
Nessuno di questi media ha poi riportato la notizia della manifestazione fallita, alla quale hanno partecipato meno di 50 manifestanti, ma nel frattempo hanno accettato di fare da cassa di risonanza prima dell'azione e hanno deciso di tacere dopo il grande flop.
Inoltre, il messaggio che l'opinione pubblica ha ricevuto dai media, con la loro copertura parziale e fuorviante, è stato che c'è stata una grande manifestazione contro Scientology, il che non è vero.
Caso due: Il secondo esempio riguarda i Testimoni di Geova, l'osservatorio statale belga sulle “sette” chiamato CIAOSN e i media.
Nell'ottobre 2018, il CIAOSN ha pubblicato un rapporto sui presunti abusi sessuali su minori commessi all'interno della comunità dei Testimoni di Geova e ha chiesto al parlamento federale belga di indagare sulla questione.
Il CIAOSN ha affermato di aver ricevuto varie testimonianze da persone che sostenevano di aver subito abusi sessuali, il che ha portato a una serie di perquisizioni nelle chiese e nelle case dei Testimoni di Geova.
L'agenzia di stampa Belga ha pubblicato una notizia flash che ha immediatamente infiammato tutti i media: “Abusi sessuali su minori tra i Testimoni di Geova? Il Centro di informazione sulle sette chiede un'indagine”. Molto presto, come era prevedibile, il punto interrogativo è scomparso dal titolo dei media online:
Ventiquattro minuti dopo, La Libre Belgique e La Dernière Heure hanno pubblicato un articolo dal titolo «Abusi sessuali su minori tra i Testimoni di Geova: è necessaria un'indagine».
Successivamente, Le Soir, un altro importante quotidiano, ha fatto un ulteriore passo avanti, pubblicando un articolo dal titolo «Come i Testimoni di Geova in Belgio mettono a tacere gli abusi sessuali sui minori all'interno della loro comunità».
La stessa sera, il canale televisivo francofono belga RTBF annunciò nel suo telegiornale che il CIAOSN stava chiedendo alla Camera dei Rappresentanti di istituire una commissione d'inchiesta sui possibili abusi sessuali “tra” i Testimoni di Geova. Inoltre, la RTBF pubblicò sul suo sito web un articolo intitolato «Abusi sessuali su minori tra i Testimoni di Geova? Il Centro di informazione sulle sette chiede un'inchiesta».
Queste accuse di violenza sessuale sono state fortemente contestate dalla comunità religiosa. I Testimoni di Geova hanno ritenuto che ciò fosse pregiudizievole per loro e per la loro reputazione e hanno portato il caso in tribunale.
Quattro anni dopo, nel giugno 2022, il Tribunale di primo grado di Bruxelles si è pronunciato a favore dei Testimoni di Geova e ha condannato il CIAOSN.
Il Tribunale di primo grado di Bruxelles ha inoltre ordinato allo Stato belga di pubblicare la sentenza sulla homepage del CIAOSN per sei mesi.
La decisione del tribunale è stata accolta con favore dai Testimoni di Geova, ma pochissimi media hanno pubblicato la sentenza. Purtroppo, a quattro anni dalle accuse infondate rese pubbliche, la maggior parte dei cittadini belgi continuerà a credere che ci siano stati casi istituzionali di abusi sessuali nelle congregazioni dei Testimoni di Geova e che la loro gerarchia abbia insabbiato tali fatti criminali.
Il motivo per cui ho preso questi due gruppi come esempio è che sono i soliti capri espiatori degli anti-sette e dei media, ma possono permettersi di andare in tribunale per difendere i propri diritti. Decine di altri piccoli gruppi religiosi e spirituali non hanno la capacità finanziaria di combattere in tribunale per anni. Inoltre, i media hanno la cattiva abitudine di ignorare sistematicamente le richieste di diritto di replica di tali gruppi.
Da cattive pratiche a buone pratiche
Questo clima di ostilità, intolleranza e talvolta odio nei confronti dei gruppi religiosi o di credo marginali in molti paesi europei, che di solito gode di totale impunità, è stato chiaramente denunciato nell'ultimo rapporto dell'USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom).
Nella sezione dedicata all'anticultismo, si sottolinea che «diversi governi dell'UE hanno sostenuto o facilitato la diffusione di informazioni dannose su alcuni gruppi religiosi».
Per citarne solo alcuni, è certamente il caso della Germania, dell'Austria, della Francia e del Belgio, che hanno creato i cosiddetti osservatori delle sette a livello locale o nazionale. Tali istituzioni statali appaiono sempre più illegittime nel loro modus operandi alla luce di una serie di decisioni della Corte europea che, tra l'altro, mettono chiaramente in guardia dall'uso del termine «setta» – o «cult» in altre lingue – perché alimenta sospetti indebiti, stereotipi e ostilità nei confronti di alcuni gruppi religiosi o di credo pacifici e rispettosi della legge.
Per riassumere le osservazioni dell'USCIRF:
- Gli anti-sette creano dal nulla delle “sette” che descrivono come “pericolose o dannose per la società”.
- i media, che prosperano sul sensazionalismo piuttosto che sui fatti, sfruttano la questione delle “sette” come un argomento interessante perché aumenta le vendite o l'audience,
- gli Stati, disinformati dagli anti-sette, si sentono obbligati a proteggere i propri cittadini da questo flagello e creano leggi eccezionali e organismi repressivi specializzati, come la Miviludes e la “polizia delle sette” in Francia.
Le associazioni anti-sette, i media e le istituzioni statali anti-sette trasmettono un messaggio di sfiducia, minaccia e pericolo, creando un clima di sospetto, intolleranza, ostilità e odio nella società.
Infatti, quando i media e le istituzioni statali etichettano alcuni gruppi come pericolosi per la società, trasmettono ad alcune menti instabili il messaggio che liberarsi, “in un modo o nell'altro”, di questi elementi pericolosi è un atto “civico” legittimo.
Numerosi rapporti evidenziano l'impatto pericoloso che la stigmatizzazione di alcuni gruppi religiosi o di credo può avere su di essi e sui loro membri:
- atti di vandalismo nei luoghi di culto della comunità dei Testimoni di Geova in Italia,
- minacce di attentati dinamitardi anonimi,
- minacce di morte,
- individui armati che fanno irruzione nei luoghi di culto, come nel caso della Chiesa di Scientology in Francia,
- l'uccisione di sette Testimoni di Geova in Germania.
Questo fenomeno e l'intolleranza nei confronti delle minoranze religiose e di credo erroneamente etichettate come “sette” non esistono nei paesi in cui non esistono organizzazioni anti-sette.
Taiwan, dove sono stato recentemente invitato a partecipare a un forum internazionale sulla libertà religiosa, è un ottimo esempio di buona pratica in questo senso. Non vi è alcuna intolleranza sociale o statale, nessuna vittima di informazioni distorte o false, emarginazione, discriminazione, incitamento all'odio o crimini d'odio. Nulla di tutto ciò viene riportato dai media taiwanesi e, di conseguenza, non vi sono atteggiamenti e politiche governative infondate nei confronti di gruppi come i Testimoni di Geova o Scientology.
Conclusione
In conclusione, le democrazie europee non hanno il diritto di dare lezioni agli altri in materia di intolleranza religiosa e discriminazione. Dovrebbero talvolta essere abbastanza umili da seguire le buone pratiche di altri paesi.
Per sradicare la diffusione dell'intolleranza e dei crimini d'odio contro le minoranze religiose in Europa, il loro obiettivo dovrebbe essere:
- ricordare ai media di rispettare gli standard etici riconosciuti a livello internazionale quando trattano questioni religiose,
- stimolare l'organizzazione di workshop professionali per giornalisti e operatori dei media su come trattare le questioni relative alle minoranze religiose, senza incitare sospetti e ostilità illegittimi,
- dire agli Stati europei di astenersi dallo stigmatizzare specifiche minoranze religiose o di credo e di seguire le decisioni della Corte europea.
Fonte: HRWF